
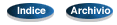
M.D.
numero 29, 11 ottobre 2006
Riflessioni
Autorevolezza del medico di famiglia tra bisogni
reali e indotti
di Ivano Cazziolato - Medico di Famiglia,
psicoterapeuta, Marcon (VE), AIMEF - Dipartimento di Neuroscienze
È
la dimensione relazionale il terreno più proficuo e idoneo
per affrontare la sfida che i cambiamenti del contesto socio sanitario
e l’aumento della domanda di salute impongono alla medicina
di famiglia. Per rispondere adeguatamente a questo bisogno è
necessaria una formazione specifica orientata in questa direzione
E'
difficile scrivere del proprio tempo e intorno alla professione
che si svolge, cercando di coglierne non solo il senso, ma soprattutto
verso quali mete si sta andando, quale sarà la medicina
dei prossimi anni, il ruolo e le sfide che spetteranno ai medici
di famiglia (MdF). Ciò che forse il MdF percepisce maggiormente
è una spinta al cambiamento e al nuovo, spinta che ha avuto
grandi accelerazioni in questi ultimi anni.
I medici, protagonisti anche loro malgradono di un sistema in
continuo fermento, non sempre avvertono la sensazione che la nuova
sanità porterà anche una ventata di gratificazione.
C’è il timore che quanto si sta facendo non va bene,
non corrisponde a un reale bisogno, del resto non si può
non rischiare ricercando il nuovo: se pensiamo per esempio che
la prima della Traviata andata in scena a Venezia, al Teatro la
Fenice, fu fischiata, ci si rende conto che non sempre il cambiamento
di costume e la novità sarà accolta con un applauso.
Proprio per questo ritengo necessario porci delle specifiche questioni,
chiederci se ci siamo interrogati abbastanza sull’annosa
domanda della relazione con il paziente: da quale punto di vista
l’abbiamo osservata? Da quello del paziente, dal nostro,
da entrambi? Ci accorgiamo più dell’irritazione del
paziente, ma riusciamo a riconoscere a sufficienza la nostra irritazione?
Stiamo andando verso la fibrillazione del sistema o verso un sistema
già in fibrillazione? Ha ancora un significato parlare
d’autorevolezza del medico di famiglia oggi?
Verso una sanità che cambia
L’ultimo decennio che ci ha visto protagonisti è stato
caratterizzato da una continua e sistematica dismissione di ospedali
periferici con l’intento di aggregare in macroaree, reparti,
ambulatori e servizi, nel tentativo di contenere la vertiginosa
spesa sanitaria che cresce ogni anno in modo esponenziale.
Sono state introdotte le UTAP, le associazioni, la medicina di
gruppo, tutte forme di aggregazione interessanti, purché
non scimmiottassero ciò che a livello centrale sta per
essere dismesso, creando dei surrogati che da un punto di vista
qualitativo, anziché rappresentare un valore aggiunto,
finiscono per ricreare sul territorio numerosi piccoli punti di
primo intervento dove si fa molto e magari peggio.
C’è un tema che ha a che fare con la fibrillazione
e riguarda l’aumento della domanda di salute, aumento che
non sempre corrisponde a reali bisogni se non quelli che rischiano
di vederci occupati nella ricerca della patologia del pelo
superfluo. Su questo argomento una bella responsabilità
l’hanno anche i sindacati: talvolta sembrano lavorare più
nella direzione dell’incremento della fibrillazione che in
quello della cardioversione.
Una certa adesività a domande di salute che sottendono
a bisogni irrazionali non dichiarati ma sperati, del tipo “dammi
l’immortalità”, accrescono la spesa sanitaria,
la fibrillazione del paziente e la frustrazione del medico. Non
sarà certo facendo lavorare di più i medici di famiglia
che si troverà la cura più adatta a questa fibrillazione
cronica e recidivante, ma attuando la cardioversione, di cui pare
non occuparsi nessuno. Forse è impopolare, ma probabilmente
è necessaria a evitare un arresto cardiaco. A volte sono
necessarie scelte coraggiose. Un ticket sull’accesso agli
ambulatori della medicina di famiglia nel 2006 è ancora
un tabù? Eppure con quel ticket si potrebbero finanziare
dei progetti, sulla prevenzione primaria, su un’educazione
alla salute, sull’alcol, sul fumo, sulla droga, sulle malattie
sessualmente trasmesse, sull’ipertensione, sul diabete, sul
cancro e perché no, perfino i nostri rinnovi contrattuali.
Progetti che vadano verso una modifica dello stile di vita piuttosto
che in richieste d’accertamenti, mentre sento meno opportuna
la creazione di un partito di medici. Ritengo politicamente più
sano che ciascuno di noi rappresenti se stesso e i propri ideali
all’interno di tutti gli schieramenti politici, o vogliamo
domani creare il partito dei medici ospedalieri, quello dei medici
specialisti convenzionati, o quello dei pediatri di base?
Quale relazione tra paziente e medico?
I corsi attivati dopo l’introduzione dell’ECM, organizzati
da Società scientifiche, aziende farmaceutiche, ASL, gruppi
di medici sono stati per lo più rivolti a svariati argomenti:
cuore, dislipidemie, osteoporosi, diabete, pneumologia, mentre
ancora troppo pochi sono i corsi dedicati al medico e alla sua
competenza relazionale. Una formazione in questa direzione è
ormai indispensabile per affrontare un lavoro ogni giorno più
complesso, ma appassionante, purché si metta il medico
nelle condizioni di rimanere al passo con i tempi, altrimenti
è come se viaggiasse in autostrada ma in una carrozza trainata
da cavalli. Ci sono a questo proposito pacchetti formativi già
collaudati da più di quindici anni, come quelli previsti
dall’Istituto di Terapia Familiare e che sono rivolti specificamente
ai medici di famiglia. Gli Istituti di Terapia Familiare sono
distribuiti in tutta Italia (www.itff.org e www.itfv.it).
Oggi il Ssn pretende di scaricare sulle sole capacità dissuasive
dei sanitari le richieste inutili d’accertamenti. L’autorevolezza
del medico non è più sufficiente a contenere un
fiume in piena di domande diagnostiche e terapeutiche che rappresentano
lo specchio dell’esuberanza d’offerta. L’offerta
è sotto gli occhi di tutti: sulle riviste, sui quotidiani,
su internet, in televisione, attraverso sms.
Sono in corso interessanti studi sul significato di “autorevolezza”,
ma penso che la questione sia all’origine.
Prima di parlare di autorevolezza, cerchiamo di osservare i cambiamenti
avvenuti nella nostra società, come per esempio si è
mutato il bisogno di salute negli ultimi venti anni e come siamo
cambiati noi MdF. Il nostro è diventato un lavoro di “accertamentificio”
e il paziente non può uscire dallo studio con richieste
d’esami disattese. Il suo potere, quindi, diventa sempre
più direttamente proporzionale alla nostra perdita d’autorevolezza
ed il rischio di una contrapposizione è forte. C’è
il medico più autorevole che forse qualche volta riesce
a dire di no, e tutti gli altri? A questo proposito, il lavorare
in un gruppo può rappresentare un vantaggio, se tutti i
membri dello stesso assumono una posizione corale quando pervengono
richieste che scientificamente non hanno fondamento. È
necessario lavorare di più e meglio sull’informazione
sanitaria e sulla prevenzione primaria. È altresì
necessario consolidare l’autorevolezza del medico attraverso
un suo percorso che lo porti a una diversa percezione di sé,
spogliandolo della zavorra che si porta dietro, facendogli recuperare
quel gap che gli fa percorrere l’autostrada seduto su una
carrozza trainata dal cavallo.
La percezione di molti medici è la sindrome dell’”assistenza
del criceto” (BMJ 2000; 321: 1541). Si tratta di un numero
sempre maggiore di sanitari che provano la sensazione di vivere
la propria giornata lavorativa girando a vuoto, come fanno i piccoli
roditori in gabbia. Una specie di wandering che vediamo spesso
in pazienti affetti da demenza. Vogliamo davvero vivere
il nostro lavoro in questo modo?
Il lavoro di gruppo
Una recente esperienza formativa AIMEF sulla gestione di gruppi
e sulla leadership ha permesso, seppure brevemente nell’arco
di due giornate, di toccare le difficoltà, ma anche le
opportunità contemplate nel lavoro di gruppo. È
stata l’occasione per far emergere conflitti, capacità
di dialogo, autorevolezza, senso del limite, leadership, confini
e un modello di gestione di tutto questo. Tutto si è svolto
in una cornice estiva come il luogo che ci ospitava, ma dove i
contenuti non sono mancati, né è mancata la voglia
di stare assieme e il desiderio di confrontarsi. È stato
dato spazio alle emozioni.
Il gruppo ha una sua storia e una sua evoluzione, non è
statico.
Bisogna distinguere tra gruppi di lavoro e lavoro di gruppo.
Il gruppo di lavoro costruisce prima il “campo”, in
altre parole la relazione. Il modo di stare insieme di un gruppo
è caratterizzato dalla tensione nel conoscersi meglio;
in pratica tende a fare emergere le risorse individuali e di gruppo.
Nel lavoro di gruppo, dove lo sfondo diventa il lavoro/compito
e la figura diventa gruppo, vale a dire relazione, spesso si guarda
troppo all’obiettivo e poco al processo.
Per fare un buon lavoro di gruppo prima va costruito un buon gruppo,
in pratica un buon gruppo di lavoro, cioè una buona relazione
gruppale; nella misura in cui il clima migliora allora diventa
più semplice guardare all’obiettivo e al compito e
lavorare bene insieme. La differenza tra gruppo e gruppo di lavoro
inizia con la differenza tra gruppo che soddisfa bisogni e gruppo
di lavoro che integra i bisogni individuali. L’esperienza
descritta è stata intensa ma ha avuto il limite di una
mancata continuità. Senza la continuità, il gruppo
non può crescere e sviluppare tutte le sue potenzialità.
Nell’emergere di un “gruppo come sistema” è
necessario che le forze, le tendenze alla complementarietà
(affinità, affiliazione, somiglianza, regole, comunicazione)
contengano e in qualche misura inibiscano e controllino le tendenze
antagonistiche (dissociazione, mutua esclusione, differenziazione).
È necessario che le tendenze alla conformità nel
gruppo integrino la diversità individuale, la comprendano
senza annullarla o appiattirla. In un gruppo di lavoro dovrebbero
presentarsi contemporaneamente il massimo della varietà
e il massimo della ridondanza.
|
|
|
|