
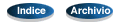
M.D.
numero 36, 30 novembre 2005
Focus
on
Salute e sistema delle cure: la sfida della
dimensione sociale
di Giuseppe Belleri, Medico di medicina generale
Flero (BS) e Monica Di Sisto
| Benché
le condizioni socioeconomiche incidano fortemente sugli
esiti di salute, tale componente è scarsamente considerata.
Si preferisce puntare sui comportamenti e gli stili di vita.
La medicina di famiglia, in quanto prima responsabile della
relazione terapeutica, ha le carte in regola per raccogliere
la sfida e superare il gap che si registra tra dimensione
sociale e dimensione clinica. |
Le
condizioni socioeconomiche incidono per il 50% sulla longevità,
intesa sia come speranza di vita sia come qualità, tanto
da creare una differenza anche di 5 anni nell’aspettativa
di vita. Il patrimonio genetico, invece, si ferma a determinare
appena il 20% dell’aspettativa di vita, una percentuale
pari a quella determinata dall’ambiente. Il resto dipende
dal Servizio sanitario del Paese dove si nasce. Eppure la percezione
della popolazione è molto differente: il peso del Servizio
sanitario nazionale superebbe, in questo caso, il 60%, mentre
la considerazione per la cultura e le condizioni socio-economiche
sfiorerebbe appena il 10%, così come la predisposizione
genetica. Un concetto sottolineato da Gianfranco Domenighetti,
direttore del Servizio sanitario Canton Ticino, nel corso dell’incontro
“Diseguaglianze sociali: il ruolo della comunicazione pubblica”,
che si è svolto a Bologna presso il Compa, il salone
europeo della comunicazione pubblica dei servizi al cittadino
e alle imprese. “La componente socio-economico non è
spesso considerata quando si parla di salute, mentre si punta
in particolare sui comportamenti e gli stili di vita - ha affermato
Domenighetti - invece ci sono tante ricerche scientifiche che
confermano una differenza di almeno 5 anni di vita tra le classi
più ricche e le meno abbienti”.
Nella speranza di vita, per esempio, si registra una forbice
di molti anni tra l’Italia, che tocca gli 80 anni, e il
Mozambico, che sfiora appena i 34. Ma si può anche considerare
il diverso ricorso alla prevenzione. Basti pensare alle “mammografie
eseguite dalle over 40: il 61.8% delle laureate e appena il
24.8% di coloro che non hanno alcun titolo di studio”,
ha evidenziato Giuseppe Fattori, direttore del Sistema di comunicazione
e marketing dell’Azienda Usl di Modena. “Stesso discorso
vale per il pap-test - ha spiegato ancora Fattori - le donne
laureate e quelle con una licenza di media superiore in Italia
si sottopongono allo screening in 7 casi su 10, chi ha la licenza
elementare in un caso su 2 e quelle senza alcun titolo di studio
in appena il 32.2%”.
Ma i Mmg sono pronti a gestire queste nuove evidenze scientifiche?
E quali scelte concrete sono pronti a mettere in campo, sia
in ambito clinico, sia scientifico-formativo?
Mmg a confronto con la dimensione sociale
Il Centro Studi e Ricerche in Medicina Generale (CSeRMeG) ha
compiuto i vent’anni dalla sua fondazione. Ha festeggiato
l’evento a fine ottobre, nell’ormai tradizionale cornice
congressuale sulla sponda veronese del Lago di Garda, affrontando
proprio questo tema difficile e inconsueto: “Determinanti
della salute, disuguaglianza, discriminazione: lo sguardo della
Medicina Generale”. Inconsueto poiché discutere
di uguaglianza/disuguaglianza riguardo alla salute evoca cornici
concettuali che esulano dalla tradizionale impostazione medica,
per sconfinare nel mondo giuridico (la natura complessa del
diritto positivo alla salute) in quello politico (uguaglianza
con caposaldo della democrazia) e dell’evoluzione storico-sociale
(il rispetto delle differenze culturali come base per l’uguaglianza).
Anche il Mmg talvolta, sebbene operi nel contesto di un sistema
sanitario equo e solidaristico, può trovarsi nell’incomoda
posizione di esercitare il ruolo di agente di giustizia locale.
Infatti quando deve prendere decisioni che possono avere risvolti
di equità sociale (per esempio far pagare un farmaco
perchè non prescrivibile a carico del Ssn in quel particolare
assistito) può scegliere in modo informale, con compromessi,
aspetti idiosincrasici ed eccezioni non sempre eque.
La ricerca epidemiologica ha affrontato spesso il rapporto tra
le condizioni socioeconomiche e la salute, per esempio mettendo
in relazione la variabile reddito e la mortalità. In
effetti per valori minimi di reddito (povertà assoluta)
è stato verificato un aumento della mortalità,
che invece si riduce proporzionalmente con l’incremento
del reddito, cioè non appena viene superata la soglia
di povertà. Riguardo all’occupazione sono stati
rilevati tassi di mortalitàno tra i lavoratori manuali
superiori rispetto al lavoro impiegatizio e così pure
le complicanze del diabete mellito sono più frequenti
tra i lavoratori non professionalizzati e tra i disoccupati.
Infine gli assistiti con basso livello di istruzione accedono
spesso ai servizi sanitari anche se non sempre le prestazioni
sono appropriate rispetto al bisogno.
Per ovviare all’influenza negativa sulla salute delle condizioni
socioeconomiche si possono adottare alcune strategie pratiche.
Il medico dovrebbe identificare sistematicamente i fattori determinanti
nel singolo paziente per un approccio clinico più attento
e personalizzato e, secondariamente, promuovere il cosiddetto
empowerment del paziente e le sue capacità di far fronte
ai principali problemi di salute (strategie di coping).
Fattori di rischio: minori solo in
apparenza
I determinanti socioeconomici della salute e delle malattie
sono stati considerati tradizionalmente alla stregua di fattori
di rischio minori o collaterali rispetto a quelli biologici,
sebbene già in passato alcune ricerche avessero messo
in luce la loro importanza. Per esempio una storica ricerca
del passato aveva documentato che le reti sociali hanno un effetto
protettivo sul reinfarto addirittura superiore ai betabloccanti.
Un’importante ricerca epidemiologica sulla patologia coronarica,
pubblicata su Lancet (2004; 364: 937-52 e 953-62), ha riportato
l’attenzione dei medici sui determinanti psicosociali della
malattia. Si tratta dello studio caso controllo sul rischio
di infarto miocardico, denominato Interheart, condotto in ben
52 Paesi in tutto il mondo, che ha permesso di quantificare
i principali fattori di rischio, già noti: fumo di sigaretta,
diabete, colesterolemia e obesità. Un po’ a sorpresa,
accanto a questi determinanti biologici, l’indagine ha
messo in luce il ruolo altrettanto rilevante delle condizioni
psicosociali, nella fattispecie povertà, disoccupazione
e depressione. Essi si sono affiancati a fattori di rischio
classici come fattori di rischio clinico cardiovascolare indipendenti
dal contesto. I fattori sociali, ha rivelato per di più
lo studio Interheart, influenzano intorno al 35% dei casi di
rischio. Se si considera che una condizione di svantaggio psicosociale
è spesso correlata ad altri fattori di rischio, come
fumo di sigaretta, ipertensione arteriosa e deficit alimentari,
si può comprendere quanto rilievo possa assumere un intervento
medico che tenti di modificare le situazioni di disagio sociale
o la vera e propria sofferenza psichica.
Fino ad ora gli studi epidemiologicici sui determinanti psicosociali
sono rimasti estranei alla pratica clinica: fanno testo in tal
senso le carte del rischio CV, che ne ignorano l’esistenza,
al pari dei fattori alimentari. Lo studio Interheart rappresenta
una novità e sollecita l’interesse dei clinici per
questi dati anamnestici, che d’ora in avanti non possono
più essere ignorati, anche perché in caso contrario
la loro significatività statistica è tale da configurare
una sorta di malapratica.
È realistico che il Mmg inserisca nell’approccio
di routine al rischio cardiovascolare anche le condizioni psicosociali?
I risultati dello studio Interheart, decisamente probanti in
quanto supportati da intervalli di confidenza assai solidi,
possono essere trasferiti alla clinica? Ormai le mappe della
disuguaglianza sono precise come quelle satellitari del territorio
e reclamano un nuovo approccio globale centrato sull’epidemiologia
del malessere sociale e di vita della gente, che troppo spesso
rimane occulto o non viene modificato anche quando vi sarebbero
le risorse per farlo. Il primo passo verso l’evitabilità
passa attraverso la percezione del problema, che si concretizza
operativamente in una definizione pragmatica del disagio psicosociale.
Ma lo studio Interheart ci mostra un dato altrettanto chiaro
e incontrovertibile: che il peso sulla condizione clinica dei
fattori psicosociali, oltre ad essere molto elevato, si mantiene
costante in tutti i 52 Paesi monitorati. Il che significa che
non basta avere migliori condizioni economiche o generali perché
la loro incidenza si riduca tra le fasce più deboli.
È per questo che la medicina di famiglia, la più
vicina ai pazienti, deve cominciare a trasferire nella clinica
quotidiana i fattori di rischio psicosociali, passando dalle
parole ai fatti.
Mmg: un passo avanti
Vittorio Caimi, presidente dello CSeRMeG, ha spiegato alcuni
dei passaggi possibili, già allo stato attuale delle
conoscenze e delle politiche pubbliche, per superare la distanza
che si registra tra dimensione sociale e dimensione clinica
anche nella medicina di famiglia, prima responsabile della relazione
terapeutica difficile che si può instaurare tra un Mmg
e i suoi pazienti svantaggiati.
“Vorrei partire da alcune iniziative abbastanza semplici,
prendiamo, per esempio, la cartella clinica. Se si raccolgono
i dati sul contesto psicosociale del paziente, come il tasso
di scolarità, il reddito, questi di prassi sono relegati
in un box tra le “informazioni varie” della cartella
mentre credo che, alla luce delle evidenze scientifiche che
si moltiplicano, sarebbe importante collocarli tra i problemi
“attivi” del paziente, nella prima parte della sua
scheda. Operare questo capovolgimento, incorporando tra i dati
sensibili quelli di tipo sociale, ci consentirebbe di tenerne
conto quanto meritano. Le ricerche ci hanno mostrato che il
rischio di tipo sociale è rilevante perché prognosticamente
è molto forte”.
Caimi ha indicato due tra i principali problemi di relazione
e di cura che i Mmg incontrano con i pazienti svantaggiati:
innanzitutto la bassa compliance dovuta per lo più alla
bassa scolarità, ma anche il fenomeno dell’inverse
care (cura al contrario), ossia del moltiplicarsi degli accessi
al sistema da parte di chi ne ha meno bisogno. “Quando
si incontra un paziente con rischio psicosociale - ha sottolineato
- è importante che il Mmg metta in campo strategie aggressive:
un approccio intensivo, non soltanto farmacologico, già
molto importante, ma anche relazionale, al pari di quando si
confronti con un forte rischio clinico”.
Secondo Caimi - che mutua un’espressione della relazione
di Gianni Tognoni al convegno CSeRMeG - sarebbe giunto il momento
di contribuire insieme ad elaborare un’epidemiologia dell’evitabilità.
“Il primo strumento elementare che - sottolinea Caimi -
penso possa contribuire è di far uscire i dati di contesto
socioeconomico dal livello basso dell’anagrafica del paziente
per inserirli nel livello alto dei problemi di salute, segnando
così un salto qualitativo importante nella quantità
e qualità dei dati epidemiologici di contesto”.
Il Mmg deve convincersi di trovarsi di fronte a “situazioni
modificabili in meglio - continua Caimi - non a livello cosmico,
di palingenesi, ma soprattutto quotidiano per cui è ora
di mettere fine al rimpallo con la società, cui ha partecipato
anche tutta la comunità scientifica”. Il passaggio
successivo per il Mmg “sarà quello di rendersi conto
come meglio collaborare con la rete formale e informale di promozione
dei diritti già attiva sul territorio, non soltanto a
livello sociosanitario, ma anche squisitamente sociale, a partire
dalla famiglia di provenienza fino ai servizi”.
La sfida sempre più importante lanciata alla sensibilità
sociale del Mmg - spiega Caimi - viene soprattutto dai migranti
“portatori, almeno nella mia esperienza, di problemi di
accesso ai servizi dovuti alla difficoltà linguistiche,
ma soprattutto alle difficoltà di relazione con i medici
legate alle aspettative diverse di benessere e a una diversa
percezione dei sintomi. Semplificazione della burocrazia, dove
non è necessario essere stranieri per sentirsi estranei,
mediazione culturale e linguistica con l’aiuto delle stesse
comunità migranti e dei nostri pazienti, sono tre passaggi
imprescindibili nella costruzione di un’immagine più
vera, più attenta alla condizione complessiva del malato,
e di risposte sempre più conseguenti e appropriate”.
Ricerche future
CSeRMeG tenterà di fornire un contributo a un’epidemiologia
più accurata del rischio sociale inserendo nell’ambito
della Ricerca R&P (Rischio e Prevenzione, studio sulla rilevanza
protettiva degli Omega 3 che oggi è in fase di reclutamento
e che durerà oltre 5 anni) un campione di popolazione
con queste caratteristiche. Anche nel rapporto con l’Università
di Monza che il CSeRMeG coltiva da diversi anni, Caimi annuncia
che si tenterà di proporre approcci diversi al paziente
con fragilità sociale.
Il passaggio più formale dove testare una prima ipotesi
di sintesi e proposta su dati di questo tipo si porrà,
senza dubbio, in una delle sessioni del congresso Wonca 2006,
l’appuntamento clou della “società delle società
scientifiche europee della medicina generale” focalizzato,
in particolare, sul problema delle disuguaglianze letto in una
chiave Nord/Sud ma non soltanto. “Vorremmo dimostrare -
conclude Caimi - che partendo dai livelli macro, attraverso
una modalità d’analisi rigorosa, è possibile
riscontrare una fragilizzazione progressiva della popolazione
cui, soprattutto come medici di famiglia, dobbiamo essere pronti
a rispondere qui e ora per non doverci condannare a una sensazione
di reciproca insoddisfazione tra Mmg e propri pazienti.
| Comunicazione
pubblica e salute: il caso svizzero |
Il
Canton Ticino, per affrontare il problema dei determinanti
sociali negativi rispetto alla salute dei propri cittadini,
ha promosso un progetto quinquennale, articolato in giornate
pubbliche e opuscoli informativi, per mettere in relazione
il loro tipo di lavoro, la classe sociale e la salute. Inoltre
è stata condotta una ricerca, per valutare se la
popolazione è d’accordo o meno sul fatto che
un basso reddito influisce negativamente sulla speranza
di vita.
Nel 2000 il campione di 1.000 persone si è detto
totalmente in disaccordo in un caso su due e d’accordo
in appena il 18%.
Alla fine della campagna informativa l’intervista è
stata riproposta e i dati sono cambiati: “Le risposte
che abbiamo avuto quest’anno ci dicono che appena il
27% non ritiene che vi sia un legame tra reddito e salute,
a dimostrazione che campagne efficaci si possono fare e
portano effetti”, ha sottolineato Gianfranco Domenighetti,
direttore del Servizio sanitario Canton Ticino, intervenuto
a Bologna al Compa. Secondo Gianni Tognoni, direttore del
Consorzio Mario Negrino Sud, la comunicazione però
deve essere differenziata in base a target ben definiti,
altrimenti, “in maniera paradossale, si aggrava la
disuguaglianza e tutto ciò che essa comporta sulla
salute: le classi che stanno meglio recepiscono il messaggio
e ne traggono giustamente vantaggio, mentre le altre non
riescono a cogliere l'informazione e non superano i problemi
di salute”. |
|
|
|
|