M.D.
numero 34, 16 novembre 2005
Rassegna
Effetti dei distruttori endocrini in gravidanza
e nell’allattamento
di Lino Del Pup, Professore a contratto di Alimentazione
e Patologieno Ostetrico-Ginecologiche, Università di
Padova
Per la protezione del feto e durante l’allattamento
è necessario conoscere gli aspetti più importanti
della sostanze inquinanti che interferiscono col sistema endocrino.
Tra i consigli pratici il più importante è quello
di variare molto l’alimentazione per ridurre la probabilità
di assumere dosi elevate dello stesso tipo di contaminante essendo
il rischio correlato alla dose
Le
conoscenze sull’effetto delle sostanze inquinanti sulla
salute umana, in particolare sulla gravidanza, sono molto frammentarie
e limitate, a fronte dell’enorme e crescente numero di
sostanze tossiche che quotidianamente introduciamo nell’organismo
tramite cibi e bevande, per via aerea o attraverso il contatto
cutaneo.
Molte delle sostanze di uso quotidiano o di recente introduzione
sono generalmente ritenute innocue, fino a prova contraria.
È molto più saggio, all’opposto, considerare
potenzialmente nociva ogni sostanza, in attesa che adeguati
studi ne confermino l’innocuità.
Gli studi di buona qualità sulla sicurezza sono tuttavia
pochi, anche perché hanno alti costi e finanziamenti
irrisori. I risultati infatti richiedono tempi molto lunghi
e la ricerca è quindi spesso priva di un immediato ritorno
economico e per di più rischia di calpestare enormi interessi.
 Distruttori
endocrini
Distruttori
endocrini
I composti chimici definiti Endocrine Disrupting Chemicals (EDC)
o “distruttori endocrini” sono un eterogeneo gruppo
di sostanze esogene caratterizzate dalla potenzialità
di interferire con il funzionamento del sistema endocrino, in
particolare con gli ormoni sessuali e la tiroide.
Gli EDC comprendono composti chimici di ampio impiego utilizzati
per scopi diversi, come per esempio pesticidi o componenti plastici,
e hanno in comune una struttura chimica tale da poter interagire
con il sistema endocrino. La classificazione di una classe così
poliedrica di sostanze è complessa. A scopo esemplificativo
si riportano in tabella 1 alcuni dei principali EDC.
Diversi EDC, tra cui i pesticidi, gli antiossidanti alimentari
e gli ormoni di origine vegetale, entrano direttamente nella
catena alimentare. Il carattere lipofilo permette agli EDC di
diffondersi attraverso la membrana cellulare, di legarsi ai
recettori per gli ormoni steroidei e di accumularsi a livello
del tessuto adiposo.
I cibi più ricchi di lipidi, come le carni o il latte,
sono la principale fonte di assunzione per l’uomo di EDC
e le persone obese ne accumulano una quantità molto maggiore
nel tessuto adiposo. Sebbene molti di questi composti, come
i bifenili policlorurati o il DDT, non siano più in uso,
l’elevata produzione e l’ampio utilizzo che se ne
è fatto in passato hanno determinato la contaminazione
di vaste aree, anche poco abitate.
Scoperta degli effetti dannosi
Negli anni ’60 furono descritti per la prima volta gli
effetti dannosi degli EDC in seguito all’osservazione che
gli uccelli rapaci, fino allora ben rappresentati nella fauna
americana, avevano smesso di riprodursi. In effetti nei nidi
delle aquile furono ritrovate grandi quantità di uova
rotte. Ciò fu attribuito agli effetti tossici del DDT
che interagiva con il metabolismo del calcio, inducendo la produzione
di uova con gusci più sottili e più fragili. no
no no no no no no
Negli anni seguenti fu notato che i pesci dei grandi laghi americani,
pesantemente contaminati con policlorurati bifenili, mostravano
problemi riproduttivi e malformazioni tiroidee. Gli uccelli
dell’area (gabbiani, rondini di mare, aquile), che si nutrivano
dei pesci, manifestavano disfunzioni simili. Nel lago Apopka
in Florida, che era stato pesantemente inquinato da pesticidi,
furono ritrovate elevate concentrazioni di EDC, responsabili
di anomalie degli organi sessuali incompatibili con la riproduzione
e che determinarono la drastica riduzione degli alligatori.
Negli anni ’70 fu riscontrata un’elevata incidenza
di tumore della vagina e di malformazioni di utero e ovaie in
adolescenti, figlie di donne trattate durante la gravidanza
con dietilstilbestrolo, ritenuto un farmaco antiabortivo. Questa
infelice esperienza non solo supporta l’ipotesi che l’esposizione
a interferenti endocrini possa determinare danni irreversibili
nell’uomo, ma evidenzia anche una particolare suscettibilità
dell’organismo nelle prime fasi di sviluppo. È ormai
unanimemente riconosciuto come la riproduzione e lo sviluppo
pre- e post-natale siano fasi biologiche particolarmente sensibili
agli effetti endocrini degli EDC.
Numerosi studi epidemiologici suggeriscono correlazioni fra
esposizione a specifici gruppi di EDC e alterazioni riproduttive,
quali malformazioni dell’apparato riproduttivo, infertilità,
aumentato rischio di seminomi ed endometriosi. Studi sperimentali
e clinici, d’altra parte, hanno consentito di mettere meglio
a fuoco l’ampio spettro di patologie correlabili con l’esposizione
a EDC. Queste comprendono l’incremento di abortività
precoce associato all’esposizione lavorativa a pesticidi,
effetti a lungo termine sulla funzionalità riproduttiva
in seguito a danni indotti in utero o durante l’infanzia,
patologie endocrino e metaboliche, come per esempio l’osteoporosi
postmenopausale, correlabili con un’alterata produzione
di estrogeni ed androgeni.
La sindrome da disgenesia testicolare è caratterizzata
da anomalie di sviluppo dei genitali maschili che deriverebbero
dall’esposizione del feto a sostanze inquinanti con effetto
estrogenico che determinano ipospadia, ovvero difetto anatomico
del pene con anomalo sbocco del meato uretrale, criptorchidismo,
scarsa produzione di spermatozoi e cancrono dei testicoli.
L’esposizione del padre a pesticidi, solventi e vernici,
determina un danno genetico negli spermatozoi e si associa a
un aumentato rischio di tumorino del sistema nervoso centrale
nella prole. Questi sono i risultati di uno studio svedese su
230.000 bambini che ha rilevato anche un aumentato rischio di
leucemia nei figli i cui padri lavorano nell’industria
del legno.
Metalli pesanti
I metalli pesanti embriotossici sono mercurio, piombo, manganese,
nichel e cadmio. Sono considerati anch’essi “distruttori
endocrini” in quanto possiedono anche un effetto simil-estrogenico.
Piombo e mercurio possono provocare aborti spontanei. Mercurio,
piombo, manganese possono provocare danni al sistema nervoso
centrale del feto e/o ritardono mentale. Piombo, manganese e
nichel possono essere causa di malformazioni congenite.
Metil-mercurio
Il metil-mercurio si accumula nella catena alimentare concentrandosi
nei grandi predatori che nella loro esistenza si sono cibati
di grosse quantità di altri esseri viventi, come lo squalo,
il pesce spada o il luccio. La Food and Drug Administration
nel 2001 ha allertato le donne in età riproduttiva, in
particolare le donne in gravidanza o che allattano, ad assumere
al massimo una volta al mese quei pesci che potrebbero contenere
dosi elevate di metil-mercurio ovvero più di una parte
per milione (ppm). Il Canada ha utilizzato livelli più
cauti di 0.5 ppm e restringe anche l’utilizzo del tonno
fresco o surgelato. La maggior parte dei prodotti ittici ne
contengono da 0.01 a 0.5 ppm. Quelli maggiormente utilizzati
e che rappresentano l’80% del mercato, ne contengono meno
di 0.2 ppm. I pesci di acquacoltura sembrano contenere meno
metil-mercurio, ma dipende dalla composizione dei loro mangimi
e non è escluso che vi siano maggiori concentrazioni
di altri inquinanti. Infine dipende molto dal livello di contaminazione
delle acque in cui i pesci e le loro prede vivono. Va considerato
che i pesci sono un’importantissima fonte di acidi grassi
omega-3 e pertanto vanno comunque assunti almeno due volte la
settimana, tentando di sceglierli in modo appropriato.
Pesticidi
I pesticidi vengono sempre più immessi nell’ambiente,
sia nei Paesi occidentali che in quelli in via di sviluppo,
con l’intento di eliminare alcune forme di vita che riducono
la produttività agricola. Purtroppo essi non sono così
selettivi da essere tossici solo per la specie che si desidera
eliminare e innocui per l’uomo e per gli altri organismi.
Per questo sono un rischio per la salute umana e per l’ambiente
in quei Paesi laddove i controlli e le attività di sorveglianza
sono meno sviluppati. L’esposizione ai pesticidi interessa
l’intera collettività, poiché si possono
trovare sia nell’acqua sia nel cibo. Inoltre va sottolineato
che i lavoratori impiegati nelle industrie produttrici di questi
composti sono più controllati ed esposti soltanto a uno
o pochi composti, mentre i lavoratori impiegati in agricoltura
sono esposti a un numero molto maggiore di sostanze e con minori
controlli sul livello di esposizione. È stato osservato
l’incremento del tempo al concepimento e del rischio di
abortività nelle compagne di lavoratori, come operatori
nelle serre e disinfestatori, esposti a pesticidi. I pesticidi
in genere possono causare aborti spontanei e deficit del SNC
del feto.
Il dibromopropano e il bromoetilene presenti nei pesticidi e
conservanti dei cibi possono causare, oltre che aborti spontanei,
anche basso peso alla nascita. Dati sui roditori indicano che
il lindano induce un incremento della mortalità e una
ridotta moltiplicazione cellulare degli embrioni prima dell’impianto.
Le donne vegetariane durante la gravidanza, quindi a maggiore
rischio di assunzione di pesticidi contaminanti i vegetali,
hanno un rischio di 4.99 volte aumentato, rispetto alle donne
onnivore, di avere figli maschi affetti da criptorchidismo.
Bifenili policlorinati
I bifenili policlorinati (PCB) contaminano l’acqua di fiumi
e laghi e si concentrano soprattutto nel grasso dei pesci grandi
predatori di acqua dolce, come salmone, trota e carpa. Essi
passano rapidamente la placenta e si trovano nel latte materno.
L’esposizione prenatale a PCB è correlata ad aborti
spontanei, ridotta crescita intrauterina e deficit dello sviluppo
neurologico di entità relativamente modesta (memoria,
comprensione verbale, lettura, ecc), ma potenzialmente con alta
incidenza e persistenza. Le evidenze sono minori per l’esposizione
neonatale nonostante il consistente passaggio di PCB nel latte
materno, dato che il neonato è più esposto, ma
meno suscettibile rispetto al feto.
Gli stili di vita modulano l’esposizione ai fattori di
rischio ambientale, per esempio un ambiente domestico “sano”
ha effetti protettivi riguardo al rischio di ritardi cognitivi
e motori associato al livello di esposizione a PCB e diossine.
Diossine
L’esposizione paterna alle diossine, in particolare alla
tetra-cloro-dibenzo-para-diossina (TCDD), nel disastro di Seveso
del 1976 è stato associato ad una riduzione del rapporto
maschi/femmine. L’esposizione durante la gravidanza alle
diossine inibisce la differenziazione mammaria e può
influenzare negativamente l’allattamento.
Ftalati
Gli ftalati sono tra le sostanze chimiche maggiormente prodotte
e disperse nell’ambiente e hanno effetto antiandrogenico,
ovvero contrario all’effetto degli ormoni maschili. Sono
ampiamente utilizzate per esempio nelle plastiche, nei colori,
nelle lozioni, nei profumi e nei farmaci per l’effetto
di ritardato assorbimento. Essi entrano nell’organismo
umano prevalentemente per via orale, tramite residui che contaminano
gli alimenti, ma anche attraverso polmoni, cute e mucose e fino
dall’epoca embrio-fetale. Negli animali gli ftalati possono
causare tumori, aborti, malformazioni, infertilità, danni
epatici e testicolari oltre che teratogenicità per l’effetto
antiandrogenico. L’epatoblastoma è un tumore embrionario
epatico umano che colpisce nell’età infantile e
che sembra dovuto a fattori ambientali piuttosto che genetici.
I neonati prematuri, o di peso molto basso, che necessitano
di terapie intensive, come intubazione, ventilazione, cateterismi
e infusioni sono molto più esposti ad alte dosi di ftalati
rispetto ai neonati che non hanno bisogno di queste cure e sono
nel contempo più vulnerabili.
Gli ftalati potrebbero essere causa o concausa della ridotta
fertilità maschile e di patologie quali tumori testicolari,
criptorchidismo e ipospadia che fanno parte della sindrome da
“disgenesia testicolare”.
Gli antiandrogeni, come gli ftalati, possono alterare la morfologia
dei genitali maschili come la distanza tra l’ano e i genitali
nei feti di madri che hanno avuto una maggiore esposizione agli
ftalati. La barriera emato-testicolare, ovvero la struttura
che protegge i testicoli dalle sostanze potenzialmente nocive
che vi giungono per via ematica, è attiva dalla pubertà
e di conseguenza i testicoli dei feti e dei bambini sono più
vulnerabili.
Fitoestrogeni
I fitoestrogeni sono sostanze vegetali, naturalmente presenti
nell’ambiente, con effetti sul nostro organismo simili
o opposti a quelli degli estrogeni. Un’alimentazione ricca
di soia e derivati sembra abbia un effetto protettivo nell’insorgenza
di alcune patologie tumorali. Le popolazioni asiatiche, giapponesi
e cinesi, mostrano infatti incidenze del tumore della mammella
(giapponesi) o della prostata (cinesi) molto più basse
delle popolazioni occidentali. L’incidenza tende ad aumentare
se queste popolazioni emigrano in altri Paesi da cui mutuano
abitudini alimentari “occidentali”. L’effetto
protettivo della soia è dovuto ai fitoestrogeni e, in
particolare, a genisteina e daidzeina. Sfortunatamente questi
due principi attivi, isolati e purificati dal contesto dell’alimento,
mostrano un comportamento ambiguo e variabile in base alla dose.
Altri alimenti (broccoli, cavoli, cavolfiori, legumi, frutti
di bosco) e persino alcuni vini rossi sono ricchi di fitoestrogeni
e hanno dimostrato un effetto protettivo nell’insorgenza
delle patologie cronico-degenerative. I singoli principi attivi
in essi presenti sono però ancora allo studio e le complesse
interazioni con tutte le altre sostanze presenti nello stesso
alimento sono ancora sconosciute. Sembra che lo stile di vita
e l’alimentazione, in particolare l’assunzione di
fitoestrogeni, ovvero sostanze di origine vegetale con effetti
estrogenici, ma anche antiestrogenici, modulino l’entità
del rischio degli EDC.
Conclusioni
È necessaria una maggiore conoscenza e attenzione agli
effetti dei distruttori endocrini, che sono largamente distribuiti
nell’ambiente, in particolare in determinati ambienti professionali,
in agricoltura e zootecnia e persino nei farmaci.
Gli EDC possono indurre, in seguito a esposizione prenatale,
abortività, ridotta crescita fetale, malformazioni ed
effetti a lungo termine e a comparsa ritardata sullo sviluppo
funzionale dei sistemi riproduttivo, endocrino e sul sistema
nervoso centrale.
Alcuni sono particolarmente suscettibili a fattori esogeni che
interferiscono con l’equilibrio endocrino a causa del particolare
assetto di enzimi deputati al metabolismo che è diverso
tra gli individui. Vi è, per esempio, un elevato rischio
di patologie riproduttive e/o su base endocrino-immunitaria
nei soggetti affetti da morbo celiaco. Le sequenze genetiche
provenienti da virus, detti retrovirus, integrate nel genoma
umano, possono essere modulate da steroidi e mostrare un’alterata
espressione in patologie autoimmuni e riproduttive. Questo implica
che un’esposizione giudicata “entro i limiti di sicurezza”,
in base a studi di popolazione, può essere in realtà
molto tossica per alcuni soggetti difficili da identificare
e proteggere a priori, in quanto magari più resistenti
a effetti di altre sostanze. Restano pertanto da chiarire molti
aspetti degli EDC, come i diversi meccanismi biologici, gli
eventuali fattori di suscettibilità e/o di rischio concomitanti,
i reali livelli di esposizione delle popolazioni e di gruppi
specifici, il livello di rischio che consegue a una data esposizione
e, soprattutto, l’intero spettro di patologie potenzialmente
associabili all’esposizione a EDC.
Il programma “Ambiente e Salute” della Commissione
Europea (www.environmentandhealth.org) individua gli EDC fra
i temi per i quali è più urgente l’incremento
delle conoscenze e l’attuazione di azioni preventive a
breve-medio termine.
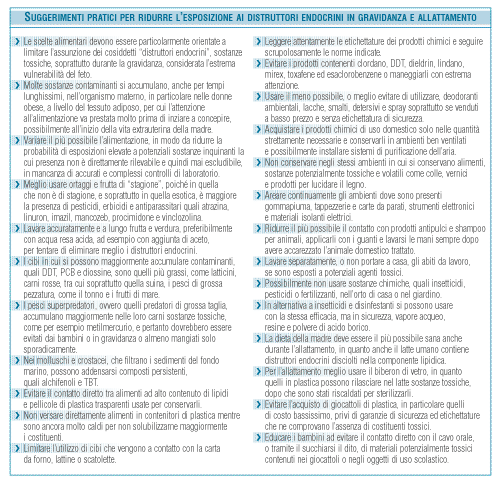
Bibliografia
disponibile a richiesta