M.D.
numero 34, 16 novembre 2005
Focus
on
Cultura antropologica come competenza del
medico di famiglia
di Massimo Bisconcin - Medico di Famiglia, Quarto dıAltino (VE)
, Dipartimento di RicercaAIMEF
La medicina di famiglia ha, più o meno consapevolmente,
utilizzato l’antropologia praticamente da sempre, ma ancora
manca un vero e proprio approccio antropologico medico disciplinarmente
integrato e trasmissibile
La
medicina di famiglia è naturalmente propensa e adatta
all’approccio individualizzato. Disciplinarmente tratta
persone e non necessariamente pazienti, approccia sofferenti
prima ancora che essi divengano malati veri e propri, quando
il motivo del contatto è ancora un “problema”
e non una “diagnosi” e, anzi, nella maggioranza dei
casi si esaurisce spontaneamente o comunque rimane in un ambito
non codificabile, anche permanentemente. Il vero medico di famiglia,
soprattutto prima che l’inquinamento normativo raggiungesse
gli attuali livelli di tossicità, è quindi abituato
ad un approccio destrutturato.
C’è tuttavia la necessità di “dare ordine
al disordine”, innanzitutto a livello di percezione culturale.
È inoltre importante che questo processo di dimostrazione
disciplinare raggiunga legislatori o amministratori da un lato
e professionisti non medici di famiglia dall’altro, ai
quali, sfortunatamente più spesso che mai, i primi ricorrono
per consulenze normative, senza mai ascoltare chi fa la Medicina
di Famiglia. Per esempio, “approccio destrutturato”
non significa affatto “approccio casuale”, quasi che
la destrutturazione fosse sinonimo di “incontro qualsiasi”
in un contesto qualsiasi e operabile da un qualsiasi “generico”
(nel senso di non formato) medico od operatore sanitario.
Approccio destrutturato significa adottare tecniche specifiche
di contatto che vanno ben oltre il tradizionale approccio clinico
anamnestico-semeiologico, che tengano conto della centralità
della persona. Centralità ha una specifica connotazione
gerarchica, in medicina di famiglia: è il medico che
si deve sintonizzare sul suo paziente in modo totale e non viceversa;
è il medico che deve preoccuparsi di farsi non solo capire
ma comprendere, ed è ancora il medico che deve decodificare
messaggi più o meno voluti o coscienti.
Centralità della persona e attenzione al contesto di
vita e di provenienza, non è puro manierismo o atteggiamento
“politicamente corretto”, quanto erogazione di vera
e propria “buona medicina”, con tutte le sue regole
e pratiche specifiche da insegnare ed apprendere.
Per mettere “ordine nell’apparente disordine”
alla disciplina Medicina di Famiglia serve anche l’antropologia.
Essa è stata definita come la più scientifica
nell’umanesimo e come la più umanistica tra le scienze,
e quindi, questo suo dilemma epistemologico ben si attaglia
a sostanziare anche il nostro.
Questione di consapevolezza
In realtà, la medicina di famiglia ha, più o meno
consapevolmente, usato l’antropologia praticamente da sempre,
ma ancora manca un vero e proprio approccio antropologico medico
disciplinarmente integrato e trasmissibile.
L’antropologia medica studia come le persone di differente
cultura, o gruppo di appartenenza sociale, interpretano e spiegano
le cause di malattia; studia inoltre come queste popolazioni
credano e si affidino ai vari trattamenti terapeutici in caso
di malattia. Si occupa inoltre, di come queste credenze o pratiche
interferiscano con la vita biologica, psicologica e sociale
dell’organismo, sia in salute che in malattia.
Una persona educata all’occidentale e al positivismo cartesiano
potrebbe essere facilmente indotta a negare che la sua vita
percettiva profonda e le sue credenze (che comunque possiede,
anche se profondamente “laiche”) abbiano una qualche
inferenza nelle sue decisioni attive verso la salute e la malattia,
quasi che le acquisizioni biomediche (provate o solo sospettate)
cancellino per palese potenza logica i suoi connotati antropologici.
Dal momento che è la cultura (dominante o no) a condizionare
i comportamenti, è comunque evidente che tutti noi siamo
soggetti antropologicamente valutabili. Per tale ragione l’antropologia
medica deve entrare stabilmente e strutturalmente a far parte
del bagaglio disciplinare e culturale della medicina generale.
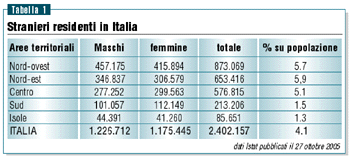 Sfida
multietnica
Sfida
multietnica
Un’altra spinta in tal senso arriva dalla sfida multietnica
alla quale noi europei siamo sottoposti. Anche se in Italia
il fenomeno è recente, risulta molto più evidente
dato il rapido incremento dei migranti e l’ancora diffusa
presenza di persone senza regolare permesso di soggiorno. I
dati Istat (tabella 1) ci dicono che gli stranieri sono più
di due milioni, l’ultima indagine della Caritas ne stima
quasi tre milioni. Questo comporta una quotidiana e significativa
presenza in ambulatorio di persone di differente gruppo etnico.
Al medico di famiglia arrivano quotidianamente persone che non
appartengono al ceppo culturale prevalente della zona in cui
esercita la sua professione. La diversità culturale agisce
comunque su cerchi concentrici: esiste una sempre più
forte mobilità regionale o nazionale ed europea (tabella
2).
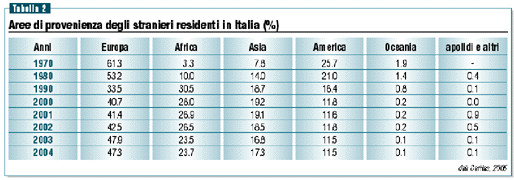 E
pur essendo l’Europa un unico soggetto (o quasi) le diversità
(linguistiche, genetiche e culturali) sono significative. Ovviamente,
nei cerchi concentrici più esterni, stanno le diversità
culturali poste dai migranti provenienti da altri continenti.
La domanda quindi diventa se tutta questa diversità culturale
interferisca significativamente con la pratica medica e, se
sì (come sembra), in quale modo. Appare evidente che
il medico debba acquisire abilità e competenze culturali
ben definite e non legate solo al suo senso sociale o all’etica
dell’accoglienza. Ogni azione della nostra vita ha connotazioni
antropologiche definite; ci sono senz’altro dei comuni
fatti quotidiani che noi diamo per scontati e, che in ogni cerchio
concentrico culturale, hanno una valenza ben definita e presuppongono
diversi comportamenti o decisioni mediche. Non è detto
che esista un vero e proprio piano di clivaggio tra ciò
che è tipico della cultura in cui si è cresciuti,
si vive e si lavora e ciò che è radialmente sempre
più eccentrico. La tabella 3, per esempio, riassume alcuni
aspetti di quotidianità e li correla ad alcuni esempi
di possibili inferenze decisionali in ambito medico. Come tale
appare che la competenza culturale non è uno strumento
che serve solo a relazionarsi con chi è molto diverso
da noi, ma anche con chi ci appare più vicino, ma che
in realtà appartiene a sottosistemi che si distinguono
in modo significativo senza essere francamente asociali o distruttivi.
E
pur essendo l’Europa un unico soggetto (o quasi) le diversità
(linguistiche, genetiche e culturali) sono significative. Ovviamente,
nei cerchi concentrici più esterni, stanno le diversità
culturali poste dai migranti provenienti da altri continenti.
La domanda quindi diventa se tutta questa diversità culturale
interferisca significativamente con la pratica medica e, se
sì (come sembra), in quale modo. Appare evidente che
il medico debba acquisire abilità e competenze culturali
ben definite e non legate solo al suo senso sociale o all’etica
dell’accoglienza. Ogni azione della nostra vita ha connotazioni
antropologiche definite; ci sono senz’altro dei comuni
fatti quotidiani che noi diamo per scontati e, che in ogni cerchio
concentrico culturale, hanno una valenza ben definita e presuppongono
diversi comportamenti o decisioni mediche. Non è detto
che esista un vero e proprio piano di clivaggio tra ciò
che è tipico della cultura in cui si è cresciuti,
si vive e si lavora e ciò che è radialmente sempre
più eccentrico. La tabella 3, per esempio, riassume alcuni
aspetti di quotidianità e li correla ad alcuni esempi
di possibili inferenze decisionali in ambito medico. Come tale
appare che la competenza culturale non è uno strumento
che serve solo a relazionarsi con chi è molto diverso
da noi, ma anche con chi ci appare più vicino, ma che
in realtà appartiene a sottosistemi che si distinguono
in modo significativo senza essere francamente asociali o distruttivi.
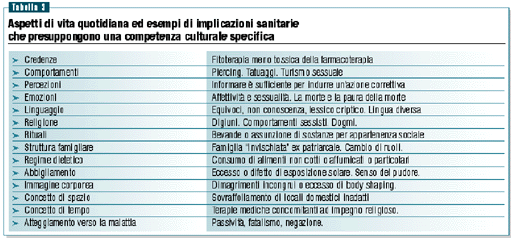 Globalizzazione:
implicazioni e pregiudizi
Globalizzazione:
implicazioni e pregiudizi
Esiste una diffusa opinione che un ipotetico evento di “non
cura” o di “rifiuto terapeutico” a favore di
altre pratiche sia un fenomeno legato ad “ignoranza”
e quindi in via di estinzione, dal momento che la globalizzazione
è percepita apparentemente come “informazione collettiva
automatica” (non si sa se come effetto positivo o collaterale).
L’uomo dell’era globalizzata, e forse anche i medici
di oggi, in fondo sono inclini a pensare che questi fenomeni,
relativamente comuni, siano legati a superstizione e quindi
appartenenti a un mondo che presto non avrà più
ragione d’essere.
Questo è un tipico errore da eccesso di positivismo,
nella consapevolezza e cieca fiducia che il “progresso
scientifico è buono” come tale, e come dogma, porti
a miglioramento automatico delle conoscenze nel senso indicato
dalla cultura dominante e questo riduca l’effetto distorsivo
della “superstizione” interpretata in modo aneddotico
e non certamente antropologico.
La diversità culturale si genera in continuazione e talvolta
porta alla formazione di veri e propri gruppi che si differenziano
e si differenzieranno dalla cultura dominante. Tale fenomeno
non sempre è imputabile soltanto all’origine etnica,
ma anche e soprattutto a credenze e a scale diverse di valori,
nei quali la lingua (lingue vere e proprie ma anche slang e
gerghi) e la religione sono e saranno solo alcune delle caratteristiche
che dovranno essere considerate.
Un test di autovalutazione
Il medico di famiglia, quindi, ha un dovere culturale immediato
e stemperato nella totalità della sua vita professionale,
legato alla sua specifica competenza antropologica. A tal fine
potrebbe sicuramente rilevarsi utile l’utilizzo di uno
strumento messo a punto da Tawara Goode della Georgetown University
(opportunamente modificato) che è una sorta di autovalutazione
sulle nostre attitudini alla diversità culturale (vedi
pagina precedente: “Test di autoverifica del proprio atteggiamento
sulle competenze culturali”).
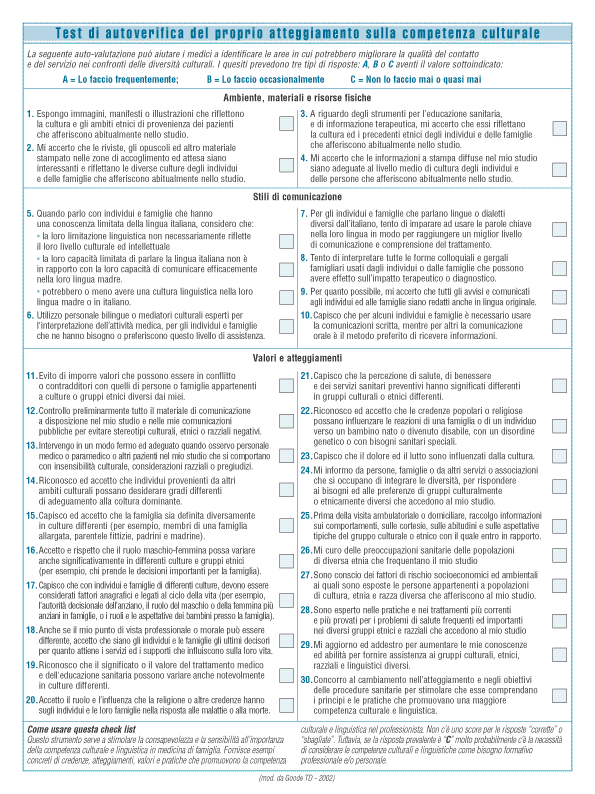
Bibliografia
• Caritas Italia, http://www.caritasroma.it/ Dossier statistico
immigrazione 2005 - XV Rapporto
• Cohen E, Goode TD. Policy Brief 1: Rationale for cultural
competence in primary health care. 1999.
• Cross TL, Bazron BJ, Dennis KW, Isaacs MR. Towards a
culturally competent system of care: Vol. I. Washington, DC:
National Technical Assistance Center for Children's Mental Health,
Georgetown University Child Development Center; 1989.
• Goode TD. Promoting cultural competence and cultural
diversity in early intervention and early childhood setting.
1989 (revised 2002).
• Helman C. Culture, health, illness. Arnold Publisher,
London, 2001.
• Istat www.istat.it
• National Center for Cultural Competence, Georgetown University
Center for Child and Human Development. Web:http://gucchd.georgetown.edu/nccc/documents/Policy_Brief_1_2003.pdf.
• Sutton M. Cultural competence. Fam Pract Manag 2000,
7(9); 58-62.