M.D.
numero 29, 12 ottobre 2005
Terapia
Attualità dei Fans nel dolore
di Angela Walmar
Il dolore muscoloscheletrico, sia di tipo acuto o cronico,
è evenienza molto frequente nella pratica clinica e il
suo trattamento viene efficacemente affidato all’impiego
di molecole analgesiche e antinfiammatorie
Il
dolore in reumatologia può essere riconducibile a numerose
situazioni patologiche, a impronta acuta o cronica. Accanto
alle sindromi dolorose acute espressione e conseguenza di un
evento traumatico, un posto di rilievo è occupato dal
dolore osteoarticolare cronico.
I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), caratterizzati
da una spiccata attività antiflogistica e analgesica,
trovano in queste patologie un campo di applicazione elettivo
in quanto in grado di agire sui due sintomi principali, il dolore
e la limitazione funzionale. Uno degli esponenti di questa classe
da lungo tempo impiegato nella pratica clinica è ibuprofene,
valutato in numerosi studi clinici su pazienti con sintomatologia
algica di pertinenza reumatologica di varia origine.
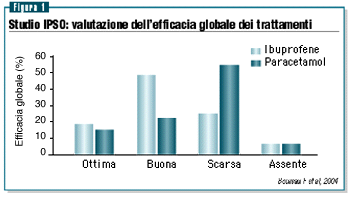 L’efficacia
analgesica di ibuprofene è stata recentemente confermata
in una della condizioni patologiche di osservazione sempre molto
frequente, l’osteoartrosi, dove rappresenta un trattamento
di efficacia paragonabile a paracetamolo, che in molti studi
viene indicato come terapia di riferimento. Lo studio IPSO (Ibuprofen,
Paracetamol Study in OA) ha confrontato l’efficacia analgesica
di ibuprofene e di paracetamolo in pazienti con osteoartrite
al ginocchio valutando l’intensità del dolore dopo
singola dose (ibuprofene 400 mg, paracetamolo 1000 mg) e la
limitazione funzionale dopo 14 giorni di terapia (ibuprofene
400 mg tid, paracetamolo 1000 mg tid) (Boureau F et al. Ann
Rheum Dis 2004; 63: 1028-1034). Lo studio ha dimostrato che
ibuprofene a dose singola o somministrato per 14 giorni è
dotato di una maggiore e più rapida efficacia rispetto
a paracetamolo (figura 1). Nel gruppo ibuprofene il punteggio
relativo alla disabilità funzionale dei pazienti è
passati da uno score iniziale di 49.2 a uno finale di 28.4,
con una differenza rispetto al basale di -20.8, mentre i medesimi
punteggi nel gruppo paracetamolo sono stati di 49.7 (basale)
e 36.3 (finale) con una differenza nettamente inferiore (-13.4).
Poiché la tollerabilità dei due trattamenti è
risultata sovrapponibile, ne deriva un rapporto efficacia/tollerabilità
a favore di ibuprofene.
L’efficacia
analgesica di ibuprofene è stata recentemente confermata
in una della condizioni patologiche di osservazione sempre molto
frequente, l’osteoartrosi, dove rappresenta un trattamento
di efficacia paragonabile a paracetamolo, che in molti studi
viene indicato come terapia di riferimento. Lo studio IPSO (Ibuprofen,
Paracetamol Study in OA) ha confrontato l’efficacia analgesica
di ibuprofene e di paracetamolo in pazienti con osteoartrite
al ginocchio valutando l’intensità del dolore dopo
singola dose (ibuprofene 400 mg, paracetamolo 1000 mg) e la
limitazione funzionale dopo 14 giorni di terapia (ibuprofene
400 mg tid, paracetamolo 1000 mg tid) (Boureau F et al. Ann
Rheum Dis 2004; 63: 1028-1034). Lo studio ha dimostrato che
ibuprofene a dose singola o somministrato per 14 giorni è
dotato di una maggiore e più rapida efficacia rispetto
a paracetamolo (figura 1). Nel gruppo ibuprofene il punteggio
relativo alla disabilità funzionale dei pazienti è
passati da uno score iniziale di 49.2 a uno finale di 28.4,
con una differenza rispetto al basale di -20.8, mentre i medesimi
punteggi nel gruppo paracetamolo sono stati di 49.7 (basale)
e 36.3 (finale) con una differenza nettamente inferiore (-13.4).
Poiché la tollerabilità dei due trattamenti è
risultata sovrapponibile, ne deriva un rapporto efficacia/tollerabilità
a favore di ibuprofene.
In un altro studio, condotto su pazienti con OA e segni di flogosi,
ibuprofene ha inoltre dimostrato di possedere la capacità
di interferire con l’aumento dei marker che riflettono
il metabolismo cartilagineo e sinoviale, suggerendo che la somministrazione
di questo Fans potrebbe prevenire, almeno parzialmente, l’aumentata
degradazione cartilaginea e sinoviale che si osserva in alcuni
pazienti (Gineyts E et al, Ann Rheum Dis 2004; 63: 857-861).
I dati più recenti non fanno che riconfermare i risultati
offerti dalla letteratura degli ultimi tre decenni. La buona
efficacia di ibuprofene è per esempio confermata anche
nella spondiloartrosi dell’anziano, patologia nella quale
riduce il dolore spontaneo, al movimento e notturno, risultando
particolarmente rapido nel generare sollievo al paziente: già
in prima giornata infatti i pazienti hanno confermato la risoluzione
del dolore spontaneo, mentre quello al movimento si è
attenuato in modo rilevante al termine della prima settimana
di trattamento (Di Peppe MC et al. Giorn Geront 1992; 40: 221-235).
Le sue possibilità di utilizzo si estendono anche al
trattamento del dolore muscoloscheletrico acuto a seguito di
un trauma, condizione in cui ibuprofene somministrato per via
orale è stato confrontato con ketorolac somministrato
per via intramuscolare. Al termine dello studio è emerso
che la somministrazione di ibuprofene per os ha determinato
una analgesia analoga a quella prodotta dalla terapia parenterale
(Turturro MA et al. Ann Emerg Med 1995; 26: 117-20).