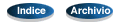
M.D.
numero 29, 12 ottobre 2005
Diario
ambulatoriale
Il lavoro in team in medicina di famiglia
- Cronaca di una settimana
di Giuseppe Maso, Medico di famiglia - Venezia, Responsabile
Insegnamento Scuola di Medicina di Famiglia, UniversitÓ di Udine
Alessandra Semenzato, Infermiera di famiglia - Venezia Docente
Scuola di Medicina di Famiglia, UniversitÓ di Udine
Lunedì
Maria
ha abortito una settimana fa. È stato un aborto spontaneo
che le è sembrato la conclusione naturale di una storia
cominciata con molte paure. Ha trentadue anni, ma come molte
donne di oggi sembra un’adolescente; è immatura
e insicura, non è assolutamente abituata ad assumersi
alcuna responsabilità, la gravidanza è stata dall’inizio
qualcosa più grande di lei. Aveva i sintomi più
disparati e pensava in continuazione a tutte le complicazioni
possibili.
Oggi è qui con il marito, anche lui sembra un adolescente,
vestito alla moda, gel nei capelli e orecchino.
L’aborto l’ha fatta cadere in una profonda depressione,
piange in continuazione e non si regge quasi in piedi, ha bisogno
di aiuto. Pensiamo al ruolo del marito e quanto sia importante
in questo periodo. Ma il marito ci fa una domanda: “Dottore
possiamo riprendere l’attività sessuale? Sa, per
le mie esigenze”. Povera Maria. Che pena e che profonda
sensazione di impotenza.
Martedì
Finalmente la moglie è riuscita a portarlo in ambulatorio.
Paolo è uno di quelli che non vuole saperne dei medici
e vi ricorre solo se costretto.
È appena stato dimesso dall’ospedale, le sue condizioni
sono veramente preoccupanti; ha cinquantotto anni, ma ne dimostra
almeno venti di più. Ricordo come era vent’anni
fa: un gran bell’uomo, sempre sorridente e felice, con
una moglie bellissima e due figli altrettanto belli.
Ma da allora non ha mai smesso di bere, se non per brevissimi
periodi in corso di complicazioni acute da abuso di alcol. Ha
una miocardiopatia alcolica, è ascitico e soffre di una
grave neuropatia.
A differenza degli altri pazienti che bevono, lui non nega,
non si giustifica né promette di smettere, anzi, ci ha
ribadito più volte la sua scelta. Lui ha deciso che non
si asterrà mai dall’alcol. Lo ha confermato più
volte anche in presenza della moglie che lo accudisce, lo capisce
e chiaramente continua ad amarlo.
Ci siamo chiesti più volte quale sia l’atteggiamento
giusto da tenere: dobbiamo continuare a insistere per curarlo
o dobbiamo rispettare il suo volere di essere lasciato in pace?
È giusto investire risorse professionali (e anche denaro
pubblico) per curare chi non vuole essere curato? È giusto
farsi carico di qualcuno che continua a farsi del male deliberatamente
ignorando ogni nostro sforzo?
Non sappiamo cosa rispondere, sappiamo comunque che, per la
nostra formazione, continueremo a tentare di fargli cambiare
idea, anche se siamo più che certi che non ci riusciremo
mai.
Mercoledì
Capita a volte di concludere la giornata con un piacevole senso
di appagamento, dovuto semplicemente a gesti spontanei e genuini
di riconoscenza dei nostri pazienti.
Così oggi, finito l’ambulatorio, mi sono recata
da un’anziana che un paio di settimane fa si era procurata
una ferita alla gamba, in casa accidentalmente. La figlia mi
ha avvertito dell’accaduto solo ieri; la settimana scorsa
eravamo in ferie. Il medico che ci sostituiva l’aveva affidata
alle cure del servizio infermieristico territoriale. Ma dopo
una settimana, essendo per la famiglia problematico recarsi
quotidianamente in ambulatorio, la signora aveva deciso di curarsi
da sola. Trascorsa un’altra settimana senza miglioramenti
ha deciso d’interpellarci.
In effetti la ferita non era di bell’aspetto, oltre alla
medicazione locale con una disinfezione più accurata
e un trattamento diverso da quello da lei praticato, richiedeva
l’assunzione di un antibiotico per via generale.
La signora ovviamente si è lamentata per il disagio subito
durante la nostra assenza, ma è stata anche contenta
del mio interessamento e delle mie cure. Ha aperto il frigorifero,
e mi ha offerto delle uova fresche e dei vasi di conserva fatta
con i pomodori del suo orto. Una dimostrazione indiretta, se
ce ne fosse ancora bisogno, che la continuità assistenziale
non si basa sulla continuità delle informazioni o del
metodo di gestione, ma sulla continuità del rapporto
personale tra il malato e chi lo cura.
Giovedì
Oggi è venuta Paola a ritirare l’esito del suo Pap
test dopo circa due mesi. Si è scusata per il ritardo,
ma ha ripreso da poco il lavoro dopo la nascita del figlio;
così non ha avuto molto tempo libero. Ha un’espressione
tristissima, che non le avevamo mai visto prima d’ora.
Vedendo il suo indugiare davanti al mio computer, le domando
come sta. In effetti, non va bene. Le hanno rifiutato la richiesta
del part-time. Il che vorrà dire stare lontano da suo
figlio almeno dieci ore al giorno.
Non è la prima volta che ci capita si sentire tutta la
tristezza, spesso l’angoscia, di queste giovani madri che
devono loro malgrado continuare a lavorare, dovendo lasciare
i propri figli alle nonne, quando va bene, o agli asili nido.
C’è di che pensare: queste ragazze, dipendenti dai
genitori, gioiscono quando trovano un lavoro e quindi la loro
realizzazione e la loro libertà, si formano una famiglia
e arriva il giorno in cui ci comunicano che forse aspettano
un figlio. Facciamo insieme il test di gravidanza, gioiamo insieme
quando compare il segno positivo. Le seguiamo per tutto l’iter
della gravidanza. Ritornano poi con orgoglio a farci vedere
il loro piccolino.
Poi il ritorno alla realtà: quel lavoro che aveva dato
loro la possibilità di realizzare un sogno, ora diventa
un peso, un ostacolo alla serenità. Che bel paradosso.
Venerdì
Oggi abbiamo tenuto un seminario agli studenti del sesto anno
del corso di laurea in medicina e chirurgia. Abbiamo deciso
di utilizzare un caso clinico come strumento didattico e abbiamo
cercato di evidenziare assieme agli studenti quali fossero le
competenze, le conoscenze scientifiche e le abilità necessarie
al medico di famiglia per gestirlo.
Ho chiesto a un collega di portare un caso tratto dalla sua
attività professionale e di esporlo agli studenti. Questi
hanno ascoltato in silenzio quasi religioso la storia umana
che emergeva e hanno commentato il caso in una maniera approfondita
ed estremamente intelligente, andando molto al di là
di quanto fosse loro richiesto. Sembrava quasi fosse la prima
volta che sentivano la storia di un uomo e non quella di una
malattia.
Ma la cosa che probabilmente li ha colpiti di più, e
che non poteva passare inosservata, è stato il coinvolgimento
del collega nell’esporlo. In quel momento lui aveva rivissuto
la storia di quel paziente che aveva assistito per vent’anni;
si percepivano chiaramente i suoi dubbi e le sue incertezze
nella gestione dei problemi che si sono presentati nell’ultima
parte dell’esistenza di quella persona. Si percepivano
chiaramente anche l’amore che aveva nei confronti del paziente
gravemente ammalato e l’amore nei confronti della sua professione.
Gli studenti stavano ascoltando un uomo a cui un altro uomo
si era completamente affidato e stavano vivendo con lui il dramma
che vive ogni medico quando si fa carico della cura di un incurabile.
Credo che si ricorderanno questo seminario.
Sabato
Siamo ormai abituati a prescrivere di tutto, non solo farmaci,
anzi per prescriverli abbiamo una miriade di limitazioni. Prescriviamo
pannoloni, carrozzine, materassi, teli di tutti i tipi, ma mai
ci era capitato di ricevere la richiesta di prescrivere un montacarichi
cingolato per un paziente non autosufficiente che vive al terzo
piano. Cominciamo ad avere qualche crisi d’identità.
Antonia stava chiedendo ad Alessandra la ricetta del suo abituale
farmaco per l’ipertensione e chiedeva anche qualcosa per
la diarrea del viaggiatore quando sono uscito dalla porta dello
studio. Mi ha sorriso come al solito; è una allegra sessantenne
che viaggia spesso senza il marito che non vuole muoversi da
casa e ha paura dell’aereo. Mi si è avvicinata con
fare furtivo e mi ha sussurrato in un orecchio, strizzandomi
l’occhio: “Vado in Tunisia, ho bisogno che mi prescriva
un lubrificante vaginale”.