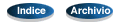
M.D.
numero 26, 21 settembre 2005
Focus
on
Come interpretare e leggere criticamente i
report Asl
di Giuseppe Belleri - Medico di medicina generale, Flero (BS)
Un appuntamento fisso quello con i report delle Asl che spesso
esita in ansia per molti medici di famiglia. La fonte di tale
disagio è la variabilità prescrittiva esaminata
e letta soprattutto in funzione della spesa. Mancano infatti
ancora adeguati sistemi di misurazione del case mix della medicina
generale, tutti da costruire per uscire da questo empasse
Per
molti Mmg è diventato un appuntamento fisso della vita
professionale, sia che venga consegnato durante riunioni di
aggiornamento a livello distrettuale sia che venga recapitato
con la corrispondenza assieme a circolari o altre comunicazioni
di servizio. Mi riferisco ai report sulla spesa farmaceutica,
sui ricoveri ecc.
Da qualche anno a questa parte infatti quasi tutte le Asl provvedono
a raccogliere ed elaborare i dati sulle prescrizioni dei singoli
medici di medicina generale per poi distribuirli agli interessati
sotto forma di report aziendali.
Formalmente il report è un documento che fornisce una
sintesi informativa sull’andamento di un servizio, finalizzata
al conseguimento di obiettivi negoziati in una logica di budget
annuale.
Un buon report deve corrispondere a tre requisiti.
1. Contenere informazioni per la verifica degli obiettivi concordati
tra unità operativa e direzione aziendale.
2. Permettere il confronto e la valutazione comparata delle
performance (benchmarking interno ed esterno).
3. Comprendere indicatori e parametri governabili dai soggetti
a cui è rivolto (centro di responsabilità).
Programmazione
e controllo
Per questi presupposti teorici il report è in primis
finalizzato al monitoraggio dei parametri relativi agli obiettivi
che sono stati preventivamente individuati, in una logica di
programmazione e controllo. Nelle imprese industriali gli obiettivi
sono generalmente di natura economico-finanziaria, ad esempio
un certo incremento annuale o semestrale del fatturato complessivo
o delle vendite di un prodotto e così via. Quindi i report
inviati ai medici in modo generico, cioè privi di una
preventiva definizione degli obiettivi da raggiungere e degli
indicatori per la valutazione, hanno un valore limitato e puramente
informativo.
Problemi e opportunità
In genere quando il Mmg riceve il proprio report trimestrale
si pone il problema di come leggere e soprattutto interpretare
i dati che “fotografano” la sua attività professionale.
Nonostante i limiti sopra accennati, i report Asl possono essere
utili per monitorare le scelte effettuate e avviare un confronto
tra pari finalizzato all’autovalutazione della qualità
professionale. A patto, però, che si evitino equivoci
interpretativi e facili trabocchetti che scattano quasi automaticamente
alla lettura dei dati.
L’errore più comune, ad esempio, sta nel considerare
le medie, relative all’Asl o al proprio distretto, come
una sorta di obiettivo ideale a cui tendere, e non è
raro che siano viste in questa chiave anche dai responsabili
distrettuali. Vi è insomma il fondato rischio che le
medie di spesa assumano implicitamente il ruolo di cut-off della
prescrizione e che i medici siano considerati normo, iper o
ipo prescrittori in relazione alla loro posizione rispetto alle
statistiche.
Vediamo schematicamente come ovviare ad alcune distorsioni indotte
dalla lettura dei report. L’interpretazione critica dei
dati deve partire da due punti d’osservazione, da due diversi
livelli dai quali è possibile leggere e valutare correttamente
le statistiche sulle prescrizioni: un punto di vista esterno
(valutazione esterna verso l’alto) e uno interno (valutazione
interna verso il basso).
Valutazione esterna e verso l’alto
Si tratta della valutazione implicita nella logica dei report,
che propongono in genere il confronto tra i dati del singolo
medico o del gruppo con quelli del distretto, dell’Asl
e della regione. Il primo problema che si pone è quello
di stabilire preventivamente qual è la media corretta
o di riferimento “a cui tendere” (ammesso che sia
metodologicamente corretto). Basta esaminare i dati della spesa
farmaceutica nazionale e locale per verificare quanta sia la
variabilità delle prescrizioni sia a livello intra che
inter-regionale. Quali sono quindi le medie di spesa “giuste”
da prendere come punto di riferimento da “imitare”?
Quelle del proprio distretto, dell’Asl vicina, dell’intera
Regione, di altre Regioni, dell’intera nazione o di altri
Paesi? Perché non inserire nel report anche i dati nazionali
o di altre Regioni? Evidentemente ha poco fondamento una valutazione
che prenda come riferimento alcune medie e non altre, indipendentemente
da considerazioni sull’appropriatezza della spesa registrata
in un’area geografica rispetto alle altre.
Oltre al parametro geografico bisogna poi considerare un’altro
problema, afferente alla dimensione locale “micro”:
qual è il legame tra lo stile professionale del medico
e le sue prescrizioni? L’esperienza del disease management
del diabete mellito per esempio, ha mostrato che la gestione
integrata della malattia diabetica e il monitoraggio metabolico
intensivo comportano un aumento dei costi rispetto al monitoraggio
tradizionale, compensato tuttavia dalla riduzione dei ricoveri
per il contenimento delle complicanze. Da qui la validità
anche economica del progetto di disease management, nonostante
l’aumento della spesa per prescrizioni di farmaci, accertamenti
diagnostici, ecc.
Ora, se applichiamo questo modello ideale, con i prevedibili
incrementi delle prescrizioni, a tutte le malattie croniche
gestite sul territorio dal Mmg avremo di sicuro una lievitazione
delle medie di spesa a carico dei medici che adottano, ad esempio,
i relativi Percorsi Diagnostici e Terapeutici (PDT). E quindi
un medico che non adottasse il monitoraggio intensivo del diabete
avrebbe sicuramente dati di prescrizione inferiori a coloro
che invece adottano il PDT. Non per questo sarebbe un ipoprescrittore
virtuoso da emulare. Anzi, probabilmente sarebbe vero l’opposto!
Le cronicità
Bisogna inoltre tenere conto che la gran parte della spesa farmaceutica
è dovuta alle terapie di lungo periodo rispetto a quelle
per episodi acuti (tipo antibiotici o FANS per riacutizzazioni).
Il 70% delle prestazioni erogate dal Ssn è rivolto alla
cura e al controllo di affezioni croniche (diabete, dislipidemia,
ipertensione, cardiopatie, asma, BPCO, depressione, malattie
rare ecc.); questi capitoli di spesa sono in continua crescita,
mentre i costi per eventi acuti sono stabili nel corso dell'esistenza.
Facili conclusioni
Dalle precedenti considerazioni si può dedurre - ipoteticamente,
salvo verifica empirica - che un livello di spesa farmaceutica
globale inferiore alle media, a parità di profilo demografico
degli assistiti e di prevalenza di patologie croniche, starebbe
ad indicare che il medico ha un difetto di qualità professionale
e non è affatto da ritenere economicamente virtuoso.
Al contrario, un surplus di spesa per farmaci cardiovascolari,
antidiabetici, antiasmatici ecc. rispetto alle medie potrebbe
essere la spia di una buona qualità professionale, a
patto di essere correlata ad indicatori di processo ed esito
migliori. Prendiamo ad esempio il caso di un medico che si impegna
nello screening dell’ipertensione (o del diabete) e quindi
potrebbe aver “scovato” un maggior numero di ipertesi
(diabetici ecc.) Conseguentemente avrà consumato più
farmaci e/o prescritto più accertamenti al fine di tenere
sotto controllo la pressione arteriosa o l’emoglobina glicata
tra i propri pazienti, mentre i ricoveri per tali patologie
potrebbero essere inferiori rispetto alle medie. Queste semplici
considerazioni suggeriscono quanto sia delicato il raffronto,
proposto implicitamente dai report, tra i dati di spesa del
singolo medico e le medie di Asl o di distretto. La teoria in
base alla quale chi spende meno della media è da imitare,
mentre chi eccede dovrebbe “rientrare in media”, è
tutta da dimostrare.
Capire le variabili
In pratica la variabilità delle prescrizioni e la discrepanza
tra i dati del medico e quelli dell’Asl può essere
dovuta all’interazione tra vari fattori causali.
-
Una
differenza significativa nella composizione della popolazione
assistita, sia in termini anagrafici sia di patologie croniche
in carico.
-
Lo
stile organizzativo e il tipo di approccio ai problemi del
medico (orientamento alla prevenzione attiva, applicazione
di linee guida o PDT, interessi culturali o specialistici,
partecipazione a ricerche o audit, motivazione o impegno personale,
lavoro di gruppo, propensione al ricovero ospedaliero ecc.).
-
Una
diversa propensione degli assistiti ad accedere allo studio
del medico ed indurre prestazioni, legata a fattori socioeconomici
e culturali (classe sociale, sensibilità verso la prevenzione,
ambiente culturale e influenza dei media, collocazione geografica
dello studio ecc.).
-
La
presenza di una vivace offerta di secondo livello (concentrazione
di strutture accreditate, pronto soccorsi, specialistica privata
e medicina non convenzionale ecc.) e di elevata concorrenzialità
interna alla categoria.
-
Una
combinazione di altri fattori, legati:
• al medico (età, sesso, anzianità di laurea,
curriculum formativo)
• agli assistiti (prevalenza di patologie rare, stagionalità)
• al farmaco e all’assetto istituzionale (vincoli
prescrittivi regionali, pubblicità e marketing farmaceutico,
rapporti con le strutture di secondo livello).
Per
poter spiegare la variabilità delle prescrizioni non è
sufficiente quindi la valutazione “esterna” e verso
l’alto (il confronto con le medie di distretto, Asl o popolazioni
più ampie) ma bisogna spostare il focus dell’analisi
e del confronto ad un altro livello, per così dire più
basso.
Valutazione interna verso il basso
Si riferisce al livello opposto rispetto a quello proposto dalle
medie prescrittive di distretto o di Asl, ovvero gli assistiti
seguiti dal medico. Le medie statistiche generali, sia della spesa
sia epidemiologiche, devono essere raffrontate e valutate tenendo
conto delle caratteristiche della popolazione in carico al singolo
professionista.
Il semplice numero dei pazienti in carico è un dato quantitativo
insufficiente per poter valutare le prescrizioni e andrà
integrato con la prevalenza delle principali malattie croniche:
quanti ipertesi, diabetici, diabetici ipertesi, coronaropatici,
broncopatici cronici, seguiti dal Mmg. Poiché le patologie
in generale, e quelle croniche in particolare, sono correlate
alla distribuzione anagrafica della popolazione, questo parametro
può spiegare in buona parte la variabilità delle
prescrizioni dovuta alle condizioni di salute della popolazione.
La “pesatura”
Per ovviare alle potenziali distorsioni dovute alle caratteristiche
della popolazione di riferimento del medico, l’Asl in genere
introduce un correttivo che tiene conto del profilo anagrafico
dei pazienti, la cosiddetta pesatura per età e sesso, che
rivede il dato grezzo del numero di scelte. Si parte dall’ipotesi
che un aumento dell’età media degli assistiti equivalga
ad un aumento di incidenza delle principali patologie croniche
(e quindi dei consumi e della spesa), indipendentemente dalle
caratteristiche del medico, dello stile organizzativo e di lavoro
del professionista o del gruppo. Tale “pesatura” è
sufficiente per rendere conto a priori (cioè senza andare
ad analizzare la composizione epidemiologica della popolazione
assistita) delle variabilità di spesa? In altri termini,
il solo dato anagrafico può surrogare la vera e propria
ponderazione clinica, vale a dire la prevalenza e la gravità
delle diverse patologie nella popolazione assistita?
A livello ospedaliero, per esempio, affinché il confronto
tra le unità operative, ad esempio chirurgiche, di diversi
ospedali sia alla pari e non viziato da bias statistici, occorre
che la casistica affrontata sia omogenea. Infatti performance
diversificate potrebbero essere spiegate da un diverso mix di
gravità nella composizione dei pazienti afferenti. I centri
con casistica più “difficile”, vuoi per l’età
dei pazienti vuoi per comorbilità cliniche, potrebbero
registrare esiti meno brillanti, in termini di mortalità
o complicazioni, rispetto a quanti invece operano una “selezione”
dei ricoverati. La valutazione comparata della qualità
delle cure, a livello nosocomiale, ha dimostrato quanto sia importate
la tipologia della casistica affrontata e, di riflesso, i sistemi
di misurazione del case mix ospedaliero. Analogamente le valutazioni
di appropriatezza delle prescrizioni, basate su parametri puramente
economici come le medie della spesa dei report Asl, sono da ”prendere
con le pinze”.
Costruire sistemi di misurazione ad hoc
Il confronto delle medie Asl con il profilo interno, ovvero la
composizione epidemiologica delle singole popolazioni (case mix),
permette di avere una fotografia più aderente alla realtà
rispetto alla pesatura per età. Ad esempio un “eccesso”
di spesa farmaceutica in un settore potrebbe essere spiegato da
un’anomala prevalenza di patologie croniche o di malattie
rara che comportano elevati costi assistenziali. Con l’introduzione
di adeguati sistemi di misurazione del case mix della medicina
generale, ancora da costruire, sarà possibile una migliore
comprensione della variabilità prescrittiva, rispetto alle
medie statistiche di spesa, e una valutazione della qualità
dei processi assistenziali del singolo medico o delle associazioni.
|