
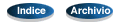
M.D.
numero 26, 21 settembre 2005
Esperienze
Disturbi funzionali intestinali: medici e
farmacisti a confronto
di Cesare Tosetti - Medico di medicina generale,
Porretta Terme (BO), Rudi De Bastiani - Medico di medicina generale,
Feltre (BL), Michele De Boni - Responsabile Servizio di Gastroenterologia,
Ospedale di Feltre (BL)
Un recente corso sulle colopatie funzionali promosso dal Gruppo
Italiano per la Gastroenterologia Ambulatoriale - Cure Primarie
ha coinvolto Mmg e farmacisti. È emersa la necessità
che tutta l’area delle cure primarie debba essere caratterizzata
dall’uso di linguaggi e atteggiamenti comuni tra le componenti,
senza rinunciare alle peculiarità professionali di ciascun
gruppo
La gestione dei disturbi
funzionali gastrointestinali non è condivisa soltanto
tra medico di medicina generale e specialista, ma anche il farmacista
viene frequentemente consultato dal paziente cercando informazioni
sui trattamenti sintomatici, eventuali novità terapeutiche,
giudizi sui rimedi suggeriti dai media o dai conoscenti, oppure
semplicemente per conferma di posologie o modalità di
somministrazione di farmaci e preparati. La professionalità
dei farmacisti può essere messa a dura prova quando il
paziente riferisce condizioni particolari o intricate, e in
questi casi la collaborazione tra Mmg e farmacista risulta fondamentale
per recuperare il paziente su percorsi corretti ed efficaci.
La diversificazione dell’offerta al banco del farmacista
(lassativi, fibre, pre e probiotici, antispastici, ecc) corrisponde
alla povertà delle armi farmacologiche disponibili per
intervenire sull’ipersensibilità viscerale o su
altri meccanismi attualmente ritenuti di grande interesse per
la patogenesi delle malattie funzionali gastrointestinali.
Il dubbio su quanto medici di medicina generale e farmacisti
si sentano preparati nella gestione di queste patologie ha suggerito
la realizzazione di un corso di formazione sulle colopatie funzionali
che si è svolto nel Distretto di Feltre (BL) ed è
stato rivolto contemporaneamente a Mmg e farmacisti per poter
offrire spunti di confronto.
Il
corso, organizzato con la collaborazione dell’Ordine
dei Farmacisti di Belluno e del Servizio di Gastroenterologia
dell’Ospedale di Feltre, è stato promosso dal
Gruppo Italiano per la Gastroenterologia Ambulatoriale -
Cure Primarie, un’associazione che riunisce rappresentanti
delle maggiori società scientifiche della medicina
generale assieme a specialisti gastroenterologi, finalizzata
alla diffusione della buona pratica clinica gastroenterologica
nelle cure primarie, attraverso la ricerca e la formazione,
ed è per questo rappresentata presso l’European
Association of Primary Care Gastroenterology.
Il corso è stato preceduto da un questionario rivolto
ai farmacisti riguardo alle difficoltà incontrate
nella pratica quotidiana nella gestione del paziente con
disturbi funzionali addominali.
I risultati del questionario evidenziano che il counselling
in farmacia è reso problematico non tanto dal rapporto
con il paziente, incluso il tempo di consultazione, bensì
dall’incertezza diagnostica e dalla difficoltà
di comprendere la sintomatologia del paziente (figura 1).
Il farmacista ritiene di potersi districare con una certa
sicurezza nell’universo dei lassativi osmotici e dei
probiotici, manifestando maggiori perplessità sulla
gestione delle fibre, degli antispastici e soprattutto dei
lassativi irritanti (figura 2).
Infine l’incertezza clinica, la difficoltà diagnostica
e la comprensione dei sintomi rimangono i maggiori ostacoli
alla gestione del paziente, mentre è percepita con
scarso disagio la mancanza di farmaci specificamente attivi
su certi aspetti fisiopatologici peculiari (figura 3).
Oltre
a questo questionario rivolto ai soli farmacisti, sono state
confrontate le risposte fornite dai 20 Mmg e dai 20 farmacisti
al questionario ECM proposto prima e dopo il corso.
La tabella 1 riporta la percentuale di risposte definibili
corrette secondo i criteri Roma II, stabiliti nel 1999 da
un gruppo di esperti che hanno preso in considerazione tutti
gli aspetti delle patologie funzionali digestive, suggerendo
schemi classificativi, valutando le ipotesi fisiopatologiche
e fornendo indicazioni terapeutiche.
|
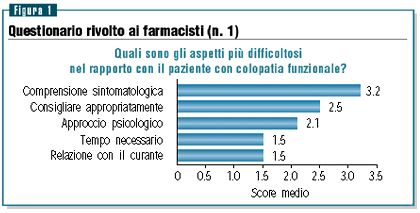
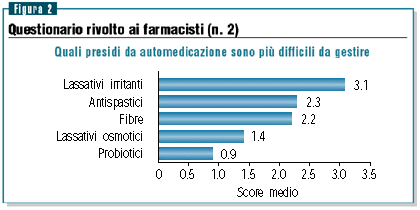
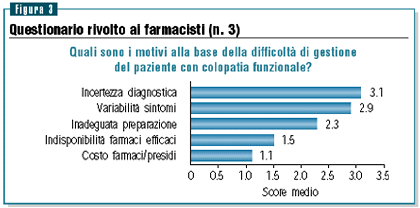
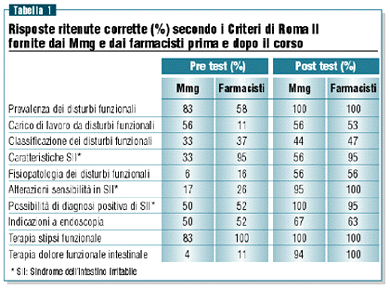
|
Risultati e riflessioni
I risultati si prestano ad alcune considerazioni interessanti.
Dal punto di vista epidemiologico c’è consapevolezza
della prevalenza della sindrome nella popolazione generale,
ma spesso il carico di lavoro indotto è risultato sovrastimato.
Se veniamo agli aspetti chiave della definizione delle sindromi
funzionali è risultato inizialmente difficile accettare
la presenza secondo i criteri Roma II di differenti sindromi
caratterizzabili secondo sintomi cardini (sindrome dell’intestino
irritabile, gonfiore addominale funzionale, stipsi funzionale,
diarrea funzionale, dolore addominale funzionale), piuttosto
che considerare tutto l’insieme delle patologie funzionali
in un unico contenitore.
Addirittura sono stati i farmacisti stessi ad avere più
chiaramente la percezione della centralità del dolore
addominale nella definizione della sindrome dell’intestino
irritabile. La fisiopatologia delle sindromi funzionali risulta
ancora complessa, anche se i risultati del post test confortano
nel verificare una disponibilità nell’accettare
le ipotesi più moderne basate sull’ipersensibilità
di tipo viscerale. La possibilità di considerare una
diagnosi positiva di patologia funzionale basata sulla storia
clinica piuttosto che operare una diagnosi puramente di esclusione
attraverso accertamenti strumentali invasivi è stata
dibattuta e accettata nel corso dell’incontro, per quanto
in precedenza considerata un po’ avventurosa. Infine, sul
versante terapeutico erano risultate decisamente meno conosciute
le possibilità terapeutiche del dolore funzionale rispetto
a quelle consolidate della stipsi.
Se confrontiamo i risultati dei farmacisti e quelli dei Mmg
possiamo notare poche differenze nelle aree grigie (diagnosi
e fisiopatologia in primis) e sostanzialmente la stessa capacità
di appropriarsi degli argomenti del corso per modificare l’atteggiamento
verso la visione attualmente più accreditata.
Questa positiva esperienza evidenzia che l’area delle cure
primarie deve essere allargata e caratterizzata da uso di linguaggi
e atteggiamenti comuni tra le componenti, basati sulle evidenze
disponibili senza rinunciare alle peculiarità professionali
di ciascun gruppo.
|
|
|
|