
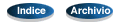
M.D.
numero 26, 21 settembre 2005
Appunti
Terapia antibiotica: raccomandazioni e pratica
A
molti medici è arrivata a fine giugno una pubblicazione
dedicata a un incontro tenuto presso l’Istituto Superiore
di Sanità in data non specificata, sul tema della terapia
antibiotica con lo slogan “Use the Best First” (usa
il migliore per primo).
Ora, se non vi sono impedimenti oggettivi (non disponibilità,
intolleranza grave, nota, ecc.), qualsiasi medico, per qualsiasi
patologia, in qualsiasi paziente utilizza per primo il farmaco
migliore. Noi medici saremo pure poco furbi, ma nessuno lo è
al punto di andarsi a cercare rogne. Dunque, mi chiedo, perché
fare una giornata di studio per promuovere ciò che per
qualsiasi medico è ovvio? Una possibile spiegazione potrebbe
essere che l’incontro sia una risposta dell’ISS alle
raccomandazioni sempre più pressanti a risparmiare sui
farmaci, scegliendo ove possibile le alternative più
economiche. E il messaggio nascosto in questa iniziativa potrebbe
essere: “Non fatevi condizionare da considerazioni monetarie
nella scelta degli antibiotici”. Infatti, guarda caso,
gli antibiotici promossi come più efficaci sono di solito
i più nuovi e i più costosi, quelli che fanno
rizzare i capelli in testa ai ragionieri del Servizio sanitario
nazionale.
C’è però un problema: che cosa vuol dire
“migliore”? A prima vista sembrerebbe che l’antibiotico
migliore sia quello che ammazza più microbi, come numero
e come varietà, nel più breve tempo possibile.
Se stiamo parlando di infezioni in malati immunocompromessi,
credo che possiamo essere tutti d’accordo. Ma quanti dei
pazienti che curiamo noi medici di medicina generale sono immunocompromessi?
E sottolinierei la parola “curiamo”. Essere il medico
il cui nome è scritto sulla tessera sanitaria è
una cosa, “curare” il paziente, cioè avere
la responsabilità terapeutica, è un’altra.
La maggior parte dei nostri pochi pazienti immunocompromessi
viene curata da centri specialistici.
Chiarito ciò, proviamo a pensare al problema principale
della farmacologia antibiotica, cioè allo sviluppo di
resistenze e a che cosa accade a due tipi di pazienti, immunocompromessi
e immunocompetenti. Il rischio di sviluppo di resistenze è
sostanzialmente identico nei due casi ed esiste per tutti gli
antibiotici. Se il centro specialistico usa un dato antibiotico
in un paziente immunocompromesso, l’eventuale resistenza
che rischia di sviluppare è totalmente dipendente dall’interazione
fra antibiotico e ceppi microbici: quelli eventualmente resistenti
vengono selezionati, punto e basta. È come se stesse
operando in vitro: meglio quindi partire subito non solo con
l’antibiotico “migliore”, ma anche a dosaggi
il più elevati possibili, nella speranza di ammazzare
così anche i microbi a resistenza intermedia. Se invece
io medico pratico uso un dato antibiotico in un paziente immunocompetente,
l’obiettivo di avvicinarmi il più possibile alla
sterilizzazione è inutile (oltre che illusorio). L’obiettivo
corretto è quello di ridurre la carica batterica a livelli
tali per cui le difese immunitarie del paziente possano avere
ragione più facilmente e velocemente della popolazione
microbica rimasta.
Le difese immunitarie non fanno distinzione fra microbi sensibili
e microbi resistenti a un dato antibiotico: se escludiamo i
casi in cui è possibile lo stato di portatore sano, li
ammazzano tutti. Ma per la stessa mancata distinzione, proprio
nel caso del portatore sano l’uso di antibiotici “potenti”
è paradossalmente più pericoloso da un punto di
vista ecologico: o lo usiamo a dosi sterilizzanti (praticamente
impossibile in vivo), o rischiamo di rendere il paziente portatore
sano, e quindi disseminatore, di ceppi resistenti proprio a
un antibiotico che potrebbe essere prezioso nei casi più
disperati. È evidente quindi, per queste considerazioni,
che “migliore” non è affatto sinonimo di più
potente: nella pratica quotidiana del medico di medicina generale
l’antibiotico migliore è quello che “aiuta”
il paziente (qui non si tratta di salvarlo, anche se a molti
di noi fa piacere crederlo), senza dilapidare le risorse finanziarie
limitate di “un’assicurazione pubblica” già
sull’orlo del fallimento.
Antonio Attanasio
Medico di medicina generale
Mandello del Lario (LC)
Domanda di salute e doveri contributivi
E'
sempre più palese la sensazione che chi lavora e chi
legifera abita due mondi diversi, non comunicanti fra loro.
Ho di recente ascoltato un’intervista all’assessore
alla Sanità della mia Regione (Friuli Venezia Giulia),
peraltro un collega. Ebbene, malgrado la comunanza professionale,
quando riveste il ruolo di politico si adegua al suo idioma.
Parla infatti un’altra lingua, incomprensibile a chi lavora
in prima linea ogni giorno.
“La qualità dell’offerta sanitaria deve essere
all'altezza della sempre maggiore richiesta di salute”,
questi, in sintesi, i suoi argomenti. Ineccepibili sul piano
teorico, ma riferiti ad una realtà che io, persona comune,
non conosco. Io vedo - e sfido chiunque a dire il contrario
- che realmente la richiesta di salute è sempre maggiore,
ma i bisogni che ne stanno all’origine non sempre sono
reali, oggettivi. Molto spesso sono indotti (dai media, dalla
pseudo educazione sanitaria, ecc.), ma, quel che è peggio,
anche dalla mancanza di un adeguato dovere contributivo per
larga parte dell’utenza.
Il nostro sistema sanitario è sul punto di implodere
perché non ci sono soldi, è questa la verità.
Ma se lo Stato, da solo, non è in grado, di garantire
l’assistenza sanitaria richiesta, allora è giunto
il momento di sensibilizzare, responsabilizzare e rendere partecipe
i cittadini. Basterebbe un solo gesto - ma ci vuole il coraggio
di scrollarsi di dosso la demagogia - per innescare un circolo
virtuoso dalle molteplici ricadute positive.
Sarebbe sufficiente insomma imporre a tappeto la partecipazione,
diversificata in base al reddito, alla presenza o meno di patologia,
rapportata al costo della prestazione, ma comunque estesa a
qualsiasi tipo di prestazione erogata dal Ssn, incluse visite
domiciliari, accessi in ambulatorio, fino alla confezione di
farmaci a basso costo.
Tale decisione potrebbe riportare alla realtà la domanda
sanitaria, educare l’utenza più che non cento trasmissioni
televisive o articoli su rotocalchi, evitare il tracollo del
sistema sanitario, anzi, porre le condizioni per un migliore
funzionamento dello stesso, anche verso quei reali bisogni che
adesso vengono affrontati in maniera insoddisfacente per mancanza
di risorse.
Vito Cavallaro
Medico di medicina generale
Pùlfero (UD)
|
Punture
|
Ristoriamoci:
è d¹obbligo |
Ad
ogni nuovo rinnovo contrattuale per la medicina di famiglia
cresce la sensazione, e con essa il disagio, che la Parte
Pubblica cerchi sempre più di equiparare i medici
di medicina generale ai medici dipendenti. La linea di demarcazione
diventa sempre più sottile. L’impressione è
che ai medici di famiglia si desideri fare scontare non
so quali privilegi, in realtà penalizzandoli rispetto
ai colleghi dipendenti, forse involontariamente (lasciamo
pure il beneficio del dubbio). L’ultima trovata? I
30 giorni di ristoro psico-fisico (non uno di più)
che, secondo il nuovo accordo collettivo nazionale, spettano
annualmente ai Mmg. È chiaro che quando il Mmg decide
di prendersi il dovuto ristoro deve darne comunicazione
all’Azienda sanitaria.
Ma tutti i dipendenti che, per un motivo o l’altro,
non usufruiscono delle ferie completamente nell’anno
hanno il diritto di cumulare i giorni mancanti sulle ferie
dell’anno successivo come recupero. Nel contratto dei
Mmg di ciò non se ne parla, tanto è solo ristoro.
Spero proprio che i colleghi abbiamo trascorso delle “ritempranti
vacanze” per potere affrontare con un diverso e ristorato
spirito i compiti professionali di tutti i giorni.
Fabio Cocconi
Medico di medicina generale, Gazoldo (MN) |
|
|
|
|