
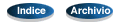
M.D.
numero 23, 22 giugno 2005
 Appunti Appunti
Da grande desidero fare il tutor
La
telefonata dall’Ordine dei Medici arriva inattesa: “Ricorda
quella domanda per il corso da tutor di qualche anno fa? È
arrivata l’ora. Lei è il primo in graduatoria. Il
corso si terrà presso l’Ordine di Bari”. Così,
con altri due colleghi, inizia il viaggio in automobile in direzione
Bari per poter partecipare al corso di formazione residenziale
su “L’attività di tutor in medicina generale.
Caratteristiche del setting tutoriale nei processi di insegnamento,
apprendimento e valutazione”. Un evento Ecm dotato
di ben 17 crediti. Come rinunciare?
D’altra parte a chi non farebbe piacere fare il tutor a
laureandi (per due settimane), ai colleghi che devono affrontare
il pre-esame di Stato (un mese), e a coloro che partecipano
al corso di formazione specifica (sei mesi) per diventare Mmg?
A dire il vero, due delle tre esperienze elencate non mi sono
nuove. Ho svolto funzione di tutor per tre colleghi del corso
di formazione specifica, con reciproca (si spera) soddisfazione
e a una studentessa della Sapienza di Roma (la figlia di un
vecchio professore di liceo) all’ultimo anno del corso
di laurea. Quest’ultima esperienza mi aveva lasciato un
po’ di amarezza stante la mancata strutturazione del tirocinio,
fatto solo per recuperare la firma di frequenza, e, forse, cosa
collegata alla prima, perché nessun rapporto, né
economico né istituzionale, si era creato con l’Università.
Perché, mi si chiederà, partecipare ad un corso
per tutor se lo si è già? Perché tale qualifica
mi era stata assegnata in Basilicata in quanto animatore di
formazione. Ma non avevo mai partecipato a un corso strutturato
per tale finalità. I requisiti minimi richiesti: anzianità
di convenzionamento con il Ssn di almeno 10 anni, carico di
assistiti superiore a 750, studio dotato dei requisiti di legge,
compresi i criteri aggiuntivi di preferenza ai fini dell’attività
tutoriale, come l’uso del personal computer e di software
gestionale, la presenza di collaboratore di studio e infermiere
professionale, l’attività di animatore di formazione,
c’erano tutti. Perché rinunciare?
Eccoci a Bari, in 40 discenti, a seguire i colleghi docenti
e animatori esperti di metodologie formative rappresentanti
le diverse società scientifiche della medicina di famiglia,
dall’AIMEF alla SIMG, dalla SIMEF alla SNAMID.
Apre il corso Giacomo Tritto presidente dell’AIMEF, sottolineando
che finalmente l’Università ha riconosciuto la MdF
come disciplina autonoma come già accade in Gran Bretagna
e Francia. Un motivo per cui diventa sempre più indispensabile
che i Mmg abbiano consapevolezza del loro ruolo, siano in grado
di trasmettere ai tirocinanti, sul campo, in ambulatorio e al
domicilio dei pazienti, l’unicità della specializzazione
in MdF.
Il corso poi procede lungo i canovacci delle competenze costitutive
della medicina di famiglia, partendo dal Documento Wonca 2002,
dai suoi contenuti didattici, con cenni a teorie pedagogiche
dell’apprendimento. Non sono mancate relazioni sul ruolo
del medico tutor, sulla tecnica di insegnamento tutoriale con
metodologia e strumenti didattici, sulla triade tutor-tirocinante-paziente,
e sul contesto normativo. L’ultimo modulo è basato
sul come valutare. Come ogni Ecm che si rispetti, al pre-test
iniziale si è contrapposto il post-test finale con inframezzate
5 esercitazioni pratiche in gruppi seguite da discussione in
plenaria. Ed alla fine ecco tutti i 40 partecipanti ritirare
i titoli di “Tutore in medicina generale”.
Non dico che sia stato come discutere la tesi, però,
lo giuro, il mio diploma è già in bella esposizione
sulla parete del mio ambulatorio. Non vorrete mica che rinunci
alla soddisfazione di esibire un nuovo titolo ai miei assistiti
anche se poi questi ci scelgono tenendo più in conto
la nostra non eccessiva intransigenza nel rilasciare certificati,
nel trascrivere ricette, per lo più specialistiche, che
quasi mai contemplano i limiti preposti dalle note AIFA. Da
domani, però, basta! Il tutor deve dare e essere d’esempio
per il tirocinante. Già, il tirocinante. La domanda fatidica,
infatti, nel ritirare l’attestato è stata: “Ma,
avremo mai un tirocinante?”. “Per ora, prenditi il
titolo - mi ha risposto un collega - poi, magari, da grande,
si vedrà”.
Filippo Mele
Medico di medicina generale
Policoro (MT)
|
Punture
|
Perché
non lasciare a noi le decisioni che riguardano il nostro
lavoro? |
Alcune
Regioni hanno già pubblicato il nuovo Piano Sanitario
Regionale (PSR), altre si accingono a farlo.
Come è noto il periodare regionalese rinnega da sempre
il fraseggio breve, chiaro e intervallato da una corretta
punteggiatura finalizzata alla comprensione degli stessi
testi. Concetti prolissi e sintatticamente mediocri riconfermano
che il linguaggio burocratico è ostico e per chi
vuol capire il come, il quando e il perché è
buio fitto (M.D. 2005; 17: 12). L’idioma dei nuovi
PSR non si discosta da ciò e non c’è
traccia di idee stimolanti. Sembra quasi che esista un “generatore
automatico di Piani Sanitari”. La prima versione del
“generatore” risale al 1982, ma di recente è
stato arricchito per far fronte alle nuove richieste della
moda burocratica sanitaria. Combinando in vario modo le
parole si possono generare più di 35 milioni di frasi,
tutte altisonanti, tutte condivisibili e tutte drammaticamente
vuote. Capita poi che qualcuno proponga delle sostituzioni
terminologiche più aderenti alla realtà.
L’Arcivescovo di Milano, per esempio, ha proposto di
sostituire il termine di azienda sanitaria con quella di
impresa sanitaria.
L’azienda verrebbe considerata come un organismo economico
diretto al raggiungimento di uno scopo. L’impresa è
definita come un’attività economica organizzata
per scambiare o produrre beni e servizi.
In effetti la medicina è una vera impresa morale.
Come il giudice o il prete, il medico prende le decisioni
attraverso un mandato esteso di fiducia. I medici sono intellettualmente
preparati a operare in autonomia decisionale.
Da questo punto di vista accettano di buon grado anche il
controllo, ma solo se esercitato da colleghi che comunque
continuano a esercitare la professione. Non tollerano invece
le autorità gerarchiche istituzionalizzate e policitizzate
che mancano di competenza operativa e di attività
esercitata quotidianamente sul campo. La sofferenza raggiunge
livelli estremi quando i medici sono costretti, da normative
regionali e aziendali, a relazionarsi con non medici gerarchicamente
sovraordinati. Lasciando al direttore generale di una ASL
una valenza più propriamente politica, ai medici
operativi dovrebbero spettare ruoli di direttore sanitario,
di distretto, dei vari dipartimenti e dei vari servizi.
Per salvare il salvabile è necessario che la gestione
e il potere ritorni nelle mani di chi opera sul campo quotidianamente
e che considera lo stesso lavoro come proprio dovere e legittimazione
del proprio stipendio.
Qualcuno, prima o poi scoprirà che il re è
nudo e senz’altro le cose cambieranno. È possibile
che si invochi, secondo la teoria dei corsi e ricorsi storici,
il ritorno del paternalismo medico, sepolto
a suo tempo con troppa fretta. Ma, a Dio piacendo, allora
dovremmo essere già in pensione.
Per ora, come sosteneva un anonimo francese del ‘700,
ci troviamo in un “cul de sac” e per uscirne ci
vorrà, verosimilmente, “un sac de…”
Dottor Luter Blisset
ex centravanti, un po’ arretrato, trequartista tattico
da centrocampo,
in pratica mediano di spinta |
Lettera aperta alla FNOMCeO e ai sindacati
Apprendo dalla carta stampata che il presidente dell’Autorità
Antitrust ha proposto per i medici di famiglia l’obbligo
di trascrivere nelle ricette il principio attivo e non il nome
commerciale dei farmaci. A tale proposta si sono opposti il
presidente della FNOMCeO e alcuni esponenti sindacali.
Mi dissocio radicalmente dalla posizione del presidente dell’Ordine
e degli esponenti sindacali e chiedo agli stessi di rispondere
alle domande che seguono.
1) Ritengono essi che i medici di famiglia abbiano e il dovere
e la possibilità di sapere se vi sono differenze sostanziali
di efficacia fra le diverse confezioni commerciali di farmaci
che contengono lo stesso principio attivo?
2) Ritengono essi che i medici di famiglia conoscano, oltre
al principio attivo, anche gli eccipienti di tutte le diverse
confezioni di farmaci che prescrivono? Se sì, vogliano
cortesemente favorire la bibliografia degli studi che dimostrano
ciò.
3) Sono essi al corrente di prove sperimentali derivate da studi
correttamente eseguiti che dimostrano differenze di efficacia
fra diverse confezioni di uno stesso principio attivo commercializzate
da case farmaceutiche diverse? Se sì, vogliano cortesemente
favorire la relativa bibliografia.
4) Sono essi consapevoli del fatto che, se le risposte alle
domande precedenti risultano negative, l’insistenza da
parte dei medici, singolarmente o tramite le loro rappresentanze
istituzionali e sindacali, a reclamare per sé il diritto
di imporre al paziente il principio attivo commercializzato
da una data casa farmaceutica e non da altre comporta il ragionevole
sospetto dell’esistenza di parzialità di determinati
medici verso determinate aziende farmaceutiche?
E non ritengono essi che tale sospetto possa nuocere al decoro
della professione?
Preciso che su tali punti attendo risposte esatte, esaurienti
e convincenti tramite gli organi di stampa destinati ai medici.
Se non dovessi ottenerle, le chiederò alla Magistratura.
Antonio Attanasio
Medico di medicina generale
Mandello del Lario (LC)
|
|
|
|