
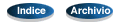
M.D.
numero 15, 27 aprile 2005
Rassegna
La gestione del paziente con malattia da reflusso
gastroesofageo
di Cesare Tosetti - Medico di medicina generale e specialista
in Gastroenterologia, Porretta Terme (BO)
La cura del paziente con MRGE può presentarsi come
un problema complesso per la varietà dei sintomi e per
la necessità di un’impostazione terapeutica adeguata
e prolungata nel tempo. La disponibilità di strumenti
diagnostici e di terapie efficaci consente la gestione in Medicina
Generale della maggior parte dei casi, riservando la condivisione
con lo specialista solo alle situazioni complicate o refrattarie
La malattia da reflusso gastro-esofageo
(MRGE) rappresenta una delle più frequenti entità
cliniche che vengono affrontate quotidianamente nella pratica
medica. La variabilità con cui la sintomatologia è
percepita a livello individuale e la complessità dell’espressione
clinica, soprattutto nelle forme atipiche, rendono difficoltosa
una valutazione precisa di prevalenza e incidenza della MRGE
nella popolazione generale, tuttavia si ritiene di osservare
un incremento progressivo, legato non solo alla maggiore attenzione
al problema, ma anche alla modificazione di fattori dietetici,
variazioni delle abitudini alimentari, problematiche legate
ai tempi e ai modi dell’assunzione degli alimenti.
Parallele modificazioni epidemiologiche sono osservabili per
fattori che esercitano rilevanti influenze sulle decisioni cliniche
nei pazienti con MRGE, quali il concomitante uso di farmaci,
l’infezione da Helicobacter pylori, l’incidenza del
cancro gastrico ed esofageo. La disponibilità di trattamenti
sempre più efficaci costituisce un motivo fondamentale
perché la MRGE debba essere prontamente riconosciuta
e affrontata sulla base di un approccio razionale.
La sfida della MRGE nella pratica medica
La MRGE rappresenta una formidabile sfida per la pratica medica,
innanzitutto perché la maggior parte dei pazienti presentano
caratteristiche per le quali possono essere completamente gestiti
all’interno della medicina generale.
Secondariamente perché la diffusione della MRGE determina
la necessità di risoluzione di problematiche di economia
sanitaria legate a un largo utilizzo di risorse di tipo sia
farmacologico sia strumentale. Un altro aspetto, non certamente
di minore importanza, è legato alle problematiche della
presentazione clinica soprattutto dei quadri cosiddetti atipici,
per i quali la collaborazione tra medico di medicina generale
e specialista (di diverse discipline) può assumere caratteristiche
di complessità e conflittualità.
L’ampia varietà dell’“espressione”
sintomatologica è paragonabile dal punto di vista problematico
all’ampia varietà di “percezione” da parte
del singolo paziente, che determina comportamenti estremamente
personalizzati soprattutto nelle motivazioni che conducono alla
consultazione medica.
Verso una gestione personalizzata del
paziente
Nella maggior parte dei casi la responsabilità della
gestione della MRGE è dunque affidata al medico di medicina
generale, nell’ambito di una pratica medica patient-oriented
piuttosto che disease-oriented. Nel rapporto medico-paziente
risulta fondamentale riuscire a comprendere le cause di consultazione,
che possono essere legate alla frequenza e alla severità
dei sintomi, ma ancora più spesso alla preoccupazione
di una patologia grave, digestiva o extradigestiva. In particolare
il paziente può essere spinto alla consultazione in modo
più o meno consapevole dal timore di una patologia neoplastica.
È evidente che il riconoscimento delle reali motivazioni
di una consultazione permette di evitare percorsi inutili, inefficaci
e scorretti dal punto di vista economico.
La frequenza e la severità dei sintomi devono essere
accuratamente valutate utilizzando non solo domande dirette,
ma anche tecniche di ascolto finalizzate al riconoscimento di
significati particolari che il paziente attribuisce alle proprie
sensazioni. In particolare il riconoscimento di sintomi tipici
quali la pirosi richiede la formulazione di domande dirette
basate su un’adeguata descrizione del fenomeno (“Ha
mai avvertito la sensazione di bruciore che dalla bocca dello
stomaco - indicare la zona - risale verso l’alto?”)
perché è dimostrato che i termini strettamente
medici non sono mai facilmente compresi da una grande parte
dei pazienti. Prima di attribuire a un problema gastrico la
dichiarazione di “mal di stomaco” occorre accuratamente
far indicare con un dito la regione di provenienza dei sintomi
per escludere sintomi sotto-ombelicali o rilevare fenomeni in
realtà a localizzazione retrosternale e attribuibili
alla MRGE.
Attraverso un adeguato ascolto sono individuabili sintomi di
allarme, quali per esempio ematemesi e melena, e sono evidenziabili
le interferenze con gli aspetti della vita quotidiana, in particolare
sul riposo notturno. Un’accurata anamnesi farmacologica
(FANS, calcioantagonisti, uso di antiacidi, ecc) è di
grande aiuto.
Capacità di ascolto ed esecuzione di un accurato esame
obiettivo sono i cardini per stratificare il rischio del paziente
rispetto a patologie gravi, capirne le richieste e interpretarne
le aspettative. È generalmente possibile individuare
forme lievi, non complicate, che possono trarre vantaggi rilevanti
dalla rassicurazione e da consigli comportamentali.
Anche se nella maggior parte dei casi che giungono all’osservazione
del Mmg è opportuno l’uso di farmaci specifici e/o
di accertamenti strumentali, la capacità rassicurativa
da parte del medico riguardo le caratteristiche e l’evolutività
della patologia risulta fondamentale. Spiegare al paziente le
caratteristiche fisiopatologiche e l’origine dei sintomi
è un’operazione che richiede un piccolo investimento
di tempo con risultati importanti sui dubbi presenti e futuri.
Accertamenti strumentali
Nell’ambito della gestione del paziente con MRGE, il Mmg
dispone dell’accesso diretto all’esofagogastroduodenoscopia,
accertamento chiave nell’individuazione di complicanze
esofagee e/o di patologie gastriche associate, ma di scarsa
sensibilità per la diagnosi di MRGE. L’esecuzione
di un esame endoscopico deve essere perciò finalizzata
a obiettivi ben precisi, tenendo conto dell’utilizzo delle
risorse.
È opportuno specificare che gli studi finalizzati a promuovere
strategie alternative a un approccio endoscopico sono stati
realizzati in particolari setting economici (generalmente nordamericani),
per i quali i costi degli accertamenti strumentali sono decisamente
più rilevanti rispetto a quelli italiani.
L’esofagogastroduodenoscopia deve perciò essere
collocata in un ben preciso piano operativo, non esitando a
ricorrervi quando possa permettere di ottenere informazioni
utili per la gestione del paziente, che non necessariamente
implicano un riscontro di lesione organica, quale esofagite
o patologia della mucosa gastroduodenale.
Studi mirati dimostrano che un risultato endoscopico negativo
per patologia organica rassicura il paziente (almeno quello
particolarmente ansioso o preoccupato), anche se la durata di
tale rassicurazione può essere di durata limitata. È
da valutare anche l’opportunità di un esame endoscopico
“una volta nella vita” per il riconoscimento di complicanze
e dell’esofago di Barrett, anche se l’evolutività
neoplastica di tale patologia è probabilmente sopravvaluta
da bias di pubblicazione.
Neppure la stessa pHmetria-24 ore può essere considerata
uno standard diagnostico dotato della necessaria efficienza
e deve essere riservata a casi particolari.
Tale esame, al pari di altri accertamenti di secondo livello
(acidimetria, test di sensibilità, manometria esofagea,
scintigrafia, ecc) deve essere ricondotto nell’ambito della
consultazione specialistica, cui è opportuno fare riferimento
nei casi di refrattarietà terapeutica, valutazione pre-chirurgica
o intricazione sintomatologica.
La valutazione radiologica dell’esofago trova indicazione
ed elezione in caso di sospetta stenosi.
Il test IPP
Una strategia diagnostica nell’ambito della MRGE proposta
soprattutto per la pratica medica è rappresentata dal
test IPP, cioè dall’utilizzo di un inibitore di
pompa protonica (IPP) ad alto dosaggio per un periodo di tempo
limitato, finalizzato a valutare un miglioramento sintomatologico.
Tale strategia è stata proposta sostanzialmente per superare
i limiti di sensibilità, costi e complessità di
endoscopia e pHmetria, ed è applicabile sia a pazienti
con sintomatologia tipica sia a quelli con patologia atipica,
quale dolore toracico non cardiaco. Il favore con il quale il
test è stato accolto è dovuto alla semplicità
di esecuzione e dalla predittività al trattamento terapeutico.
Questa metodica presenta limiti di specificità (per risposta
anche in presenza di patologia differente dalla MRGE, quale
la dispepsia funzionale, l’ulcera gastrica/duodenale o
la stessa patologia neoplastica) e dubbi di tutela medico-legale.
Inoltre, il dosaggio farmacologico e la valutazione del miglioramento
sintomatologico attualmente mancano di standardizzazione.
Dal punto di vista della pratica medica il test presenta interesse
relativo nell’ambito della diagnostica della sintomatologia
tipica, per la quale il criterio anamnestico è particolarmente
efficiente. L’interesse è altresì limitato
nella sintomatologia atipica respiratoria e ORL, in quanto sono
necessari periodi di trattamento e valutazione assai prolungati,
ma potrebbe risultare di grande efficacia nel percorso diagnostico
del dolore toracico non cardiaco dopo accurata valutazione cardiologica
e preferibilmente anche endoscopica.
Limiti del trattamento non farmacologico
La MRGE determina sulla qualità della vita del paziente
una riduzione paragonabile a quella dei pazienti con angina
pectoris, pertanto l’obiettivo del trattamento dovrebbe
essere mirato al miglioramento della qualità della vita
piuttosto che al solo miglioramento del sintomo.
Gli interventi sullo stile di vita che sono normalmente suggeriti
in corso di consultazione medica sono scarsamente supportati
sul piano bibliografico dal punto di vista dell’efficacia
sulla qualità della vita. È opportuno modificare
le abitudini alimentari del paziente suggerendo di limitare
i pasti grassi, l’assunzione di cioccolata, l’uso
di bevande gassate, di caffè e di bevande alcoliche in
genere, di evitare assunzione di cibo prima del riposo notturno.
L’elevazione della testata del letto rappresenta un accorgimento
semplice che permette buoni risultati in alcuni casi.
Non è però sicuro che questi accorgimenti permettano
un controllo sintomatologico efficace in rapporto alle difficoltà
che spesso il paziente riferisce nell’adeguarsi a queste
indicazioni.
Certamente il calo ponderale nei soggetti in sovrappeso e l’astensione
dal fumo rappresentano suggerimenti sostanzialmente imprescindibili
da ogni forma di counselling sanitario, tuttavia deve essere
ancora una volta sottolineato il ruolo importante della personalizzazione
dei consigli, lasciando che il paziente identifichi i fattori
che influenzano negativamente il proprio benessere, facendo
leva sulla capacità esplicativa e rassicurativa del Mmg
piuttosto che su quella impositiva.
Opzioni farmacologiche
Nella maggior parte dei pazienti con MRGE il trattamento farmacologico
risulta indispensabile per ottenere la guarigione di complicanze
erosive della mucosa esofagea e/o per ottenere o mantenere un
buon controllo sintomatologico.
Le strategie terapeutiche prevedono una terapia d’attacco
e una fase di mantenimento. Lo disponibilità di farmaci
che inducono un’acidosoppressione gastrica prolungata rappresenta
a tutt’oggi la migliore opzione in entrambi i casi.
Ai farmaci antiacidi è riservato un ruolo solo nelle
forme lievi, sostanzialmente in automedicazione, similmente
ai preparati ad azione locale esofagea. Questi ultimi possono
certamente risultare utili in alcuni pazienti e in fase acuta
quale terapia complementare, mentre al consumo supplementare
di antiacidi spetta il ruolo, invero rilevante, di indicatori
di inadeguato compenso farmacologico della terapia di base.
Benché la MRGE sia dal punto di vista fisiopatologico
un’alterazione motoria, ad oggi non disponiamo di farmaci
attivi sulla motilità esofago-gastro-duodenale che risultino
efficaci quanto gli antisecretori.
Gli inibitori dei recettori istaminici H2 hanno rappresentato
la svolta storica nel trattamento delle patologie acido correlate,
e tuttora rivestono un ruolo importante in alcuni pazienti per
ottenere un controllo adeguato della secrezione notturna, o,
nei casi più lievi, quale terapia on demand per periodi
brevi. Questi farmaci tuttavia presentano generalmente risultati
nettamente inferiori agli IPP, che assicurano una prolungata
inibizione della secrezione acida e quindi un mantenimento più
duraturo dei livelli di pH intragastrico necessari per il controllo
della MRGE. L’uso di questi farmaci, benché più
costosi dei precedenti, ha dimostrato che il controllo della
malattia ottenuto risulta in un risparmio economico complessivo
per la migliore gestione delle risorse, riducendo i tempi di
guarigione delle complicanze, permettendo una migliore prevenzione
delle recidive con riduzione degli accessi ospedalieri e strumentali.
Uso corretto degli IPP
Gli IPP permettono di disporre di armi efficaci per la gestione
del paziente con MRGE sia in fase acuta sia nell’utilizzo
prolungato per la prevenzione delle recidive.
Più di un decennio di esteso uso clinico ha dissipato
dubbi sulla sicurezza legata a una profonda acido-soppressione
sia per la stimolazione di cellule enterocromaffini sia per
modificazione dell’ambiente intragastrico. I dati disponibili
assicurano anche un impiego con margini di affidabilità
in gravidanza.
Attualmente sono disponibili sul mercato diversi IPP che si
caratterizzano per differenze in aspetti farmacologici che possono
essere diversamente sfruttati sul piano clinico.
Omeprazolo e lansoprazolo sono caratterizzati da affidabilità
di impiego per la lunga esperienza disponibile, compresa gastroprotezione
in terapia con FANS e altri farmaci gastrolesivi. Pantoprazolo
è stato particolarmente studiato con buoni risultati
rispetto alle interferenze farmacologiche. Rabeprazolo presenta
rapidità d’azione e peculiare metabolismo epatico
che possono risultare individualmente apprezzabili.
Sostanzialmente questi IPP possono essere considerati sovrapponibili
clinicamente quando confrontati a dosi equipotenti.
La recente disponibilità di esameprazolo, isomero attivo
di omeprazolo, permette il raggiungimento degli obiettivi acido-soppressivi
che rappresentano il target del trattamento della MRGE in un
consistente numero di pazienti.
In ogni caso il trattamento deve essere personalizzato per ogni
differente situazione. Il miglioramento di sintomi respiratori
può richiedere tempo di trattamento prolungato e dosaggio
farmacologico maggiore rispetto a una erosione esofagea.
Il trattamento della sintomatologia delle forme non-erosive
può rivelarsi particolarmente difficile, specialmente
se sostenuto da importanti alterazioni percettive da parte del
paziente, con abbassamento della soglia di sensibilità.
Nel caso di pazienti pediatrici o geriatrici le manifestazioni
cliniche possono essere differenti da quelle che il Mmg è
abituato a considerare nel giovane adulto, ma generalmente rispondono
bene alla terapia con IPP.
Alla fine degli anni ‘90 è stato acceso un dibattito
sulla comparazione tra strategie basate sul progressivo aumento
dell’inibizione acida fino a raggiungere il compenso clinico
(step up) e strategie basate sull’adozione iniziale di
una terapia massimale da ridurre successivamente fino a raggiungere
la minima dose efficace (step down). Nel corso del tempo questa
seconda ipotesi ha dimostrato un maggiore vantaggio dal punto
di vista pratico e farmacoeconomico ed è ad oggi preferibile
nella disponibilità di molecole particolarmente efficaci
e maneggevoli.
Per un uso corretto degli IPP dovrebbe essere sempre valutata
per ciascuna molecola l’adeguata assunzione rispetto alle
caratteristiche farmacocinetiche (vicinanza con i pasti, orari),
considerando una durata di terapia sufficiente per risolvere
le eventuali complicanze, abbattere i sintomi, migliorare la
qualità di vita del paziente e prevenire le recidive.
L’effetto degli interventi farmacologici dovrebbe essere
valutato sulla qualità della vita piuttosto che sul sintomo,
soprattutto nel caso delle terapie prolungate quali quelle necessarie
nella MRGE, in particolare nelle forme atipiche, con possibili
effetti su trattamenti concomitanti e conseguentemente sul loro
monitoraggio. I primi dati espressione di studi adeguati dimostrano
un effetto benefico sulla qualità della vita delle strategie
terapeutiche basate su un’adeguata acido-soppressione.
È probabile che un certo numero di pazienti necessitino
di non poter interrompere la terapia acido-soppressiva se non
per brevissimi periodi. Soprattutto per questi pazienti è
opportuno un monitoraggio periodico.
Monitoraggio del paziente
La valutazione periodica dell’intervento risulta fondamentale
nel rapporto medico-paziente. Un corretto disease management
prevede un monitoraggio del paziente piuttosto che del sintomo
o della malattia. È possibile che l’obiettivo di
una totale scomparsa dei sintomi non sia perseguibile in tutti
i pazienti, ed è perciò importante stabilire col
paziente obiettivi realistici in funzione delle condizioni e
delle aspettative individuali.
Il programma che è stato discusso e concordato col paziente
deve essere rivalutato periodicamente e in ogni occasione nella
quale si presentino mutazioni rilevanti o impreviste delle condizioni
cliniche.
Questo può accadere anche in condizioni quali la gravidanza
o l’uso concomitante di trattamenti farmacologici.
Lo stesso utilizzo prolungato di terapie acido-soppressive deve
essere monitorizzato e adeguato a mutate condizioni cliniche,
ponendosi il problema di una rivalutazione o di una switch-therapy
qualora i risultati raggiunti tendessero a ridursi nel tempo.
Di una certa rilevanza è il problema della gestione dell’infezione
da Helicobacter pylori che può coesistere in questi pazienti
e che si ritiene non presenti particolare influenza sulla patogenesi
della MRGE.
È stato evidenziato, anche se non successivamente costantemente
confermato, una maggiore progressione di atrofia gastrica in
caso di uso prolungato di IPP in presenza di infezione gastrica
di Helicobacter pylori.
È ritenuto corretto, in caso infezione gastrica da Helicobacter
pylori ottenuta per esempio in caso di esecuzione di esofagogastroduodenoscopia
discutere col paziente l’effettivo significato del riscontro
e proporre l’eradicazione, tenendo in considerazione che
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto
al batterio un ruolo quale agente carcinogenetico di prima classe.
Conclusioni e prospettive
La gestione pratica del paziente con MRGE può presentarsi
come un problema complesso per il Mmg a causa della variabilità
della presentazione sintomatologica e della necessità
di un’impostazione terapeutica adeguata e prolungata, con
monitoraggio periodico. La disponibilità di efficaci
farmaci acido-soppresori consente la gestione della maggior
parte dei casi entro la Medicina Generale, riservando la condivisione
con lo specialista solo dei casi complicati o refrattari.
La gestione razionale delle risorse disponibili, intesa come
uso appropriato sia degli accertamenti strumentali sia dei farmaci,
è necessaria per permettere di cogliere gli obiettivi
assistenziali nel rispetto dei margini economici.
Adeguati programmi educazionali rivolti collaborativamente a
medico di medicina generale e specialista sono necessari per
ottenere una migliore gestione del paziente con MRGE.
Bibliografia
-
Dent
J, Brun J, Fendrick AM on behalf of the Genval Workshop Group.
An evidence-based appraisal of reflux disease management -
the Genval Workshop Report. Gut 1999; 4: S1-S16.
-
Dent
J. Definitions of reflux disease and its separation from dyspepsia.
Gut 2002; 50: 17-20.
-
DeVault
KR, Castell Do. Updated guidelines for the diagnosis and treatment
of gastroesophageal reflux disease. The Practice Parameters
Committee of the American College of Gastroenterology. Am
J Gastroenterol 1999; 94: 1434-42.
-
Elsendrath
P, Tack J, Devtere J. Diagnosis of gastroesophageal reflux
disease
in General Practice: a Belgian National Survey. Endoscopy
2002; 34: 998-1003.
-
Fass
R, Ofman JJ, Gralnek JM et al. Clinical and economic assessment
of the omeprazole test in patients with symptoms suggestive
of gastroesophageal reflux disease. Arch Inter Med 1999; 139
:2161-8.
-
Glise
H, Wiklund I. Health-related quality of life and gastrointestinal
disease.
J Gastroenterol Hepatol 2002; 17: S72-S84.
-
Jones
RH, Hungin ADS, Phillips J. Gastroesophageal reflux disease
in primary care in Europe: clinical presentation and endoscopic
findings. Eur J Gen Pract 1995; 1: 149-54.
-
Kennedy
T, Jones R. The prevalence of gastro-esophageal reflux symptoms
in a UK population and the consultation behaviour of patients
with these symptoms. Aliment Pharmacol Ther 2000; 14: 1589-94.
-
Miner
P, Katz PO, Chen Y, Sostek M. Gastric acid control with esomeprazole,
lansoprazole, omeprazole, pantoprazole and rabeprazole: a
five-way crossover study. Am J Gastroenterol 2003; 98: 2616-20.
-
O’Connor
JB, Provenzale D, Blaser S. Economic considerations in the
treatment
of gastroesophageal reflux disease: a review. Am J Gastroenterol
2000; 95: 3356-64.
-
Ofman
JJ, Dorn GH, Fennerty MB, Fass R. The clinical and economic
impact
of competing management strategies for gastro-oesophageal
reflux disease. Aliment Pharmacol Ther 2002; 16: 261-73.
-
Shaw
M, Talley NJ, Adlis S et al. Development of a digestive health
status instrument: tests of scaling assumptions, structure
and reliability in a primary care population. Aliment Pharmacol
Ther 1998; 12: 1067-78.
-
Tosetti
C. Riconoscere un reflusso gastroesofageo: il test con IPP.
SIMG 2003; 2: 53-5.
|
|
|
|